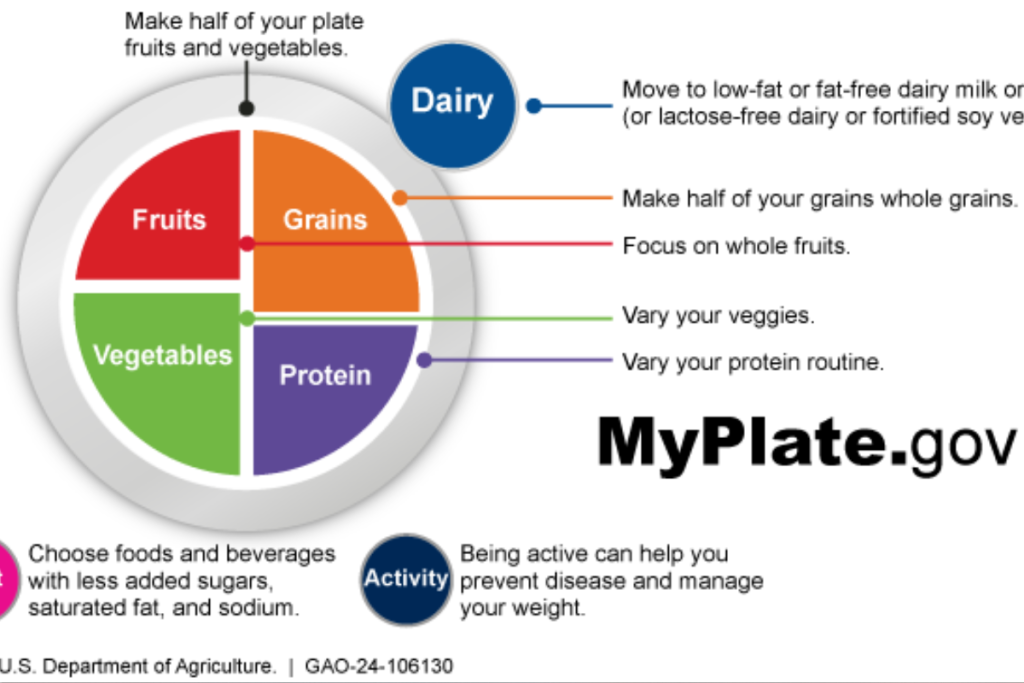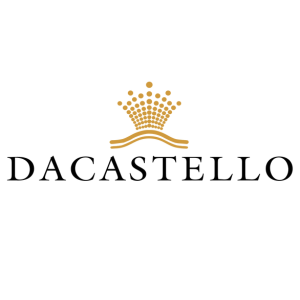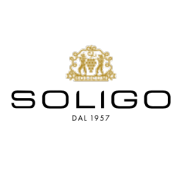Alessandro Satin, Export Manager con lunga esperienza nel settore, condivide una prospettiva provocatoria sul mondo del vino italiano. In questa intervista evidenzia i problemi di sostenibilità economica, di comunicazione e di marketing strategico che affliggono molte cantine, incoraggiando un approccio più leggero e inclusivo per attrarre un pubblico più ampio e variegato.
Alessandro Satin è fondatore e titolare di Tendervino, progetto nato per assistere le cantine italiane sui mercati monopolistici di Canada e Scandinavia; è ideatore e titolare di Export2Business, agenzia per l’export di vini e liquori italiani nel mondo. Gilbert & Gaillard gli dedica un focus sull’ultimo numero dell’autunno 2024. È da oltre 20 anni nel commercio di vino e alcolici, con significative esperienze di vita e lavoro nei mercati internazionali.
Alessandro ha raccolto la nostra recente sfida di andare insieme alla scoperta delle “verità nascoste” del vino italiano; abbiamo aperto volentieri i nostri microfoni alla sua appassionata testimonianza.
Alessandro, la ringraziamo per aver accettato il nostro invito. Può fornire ai nostri lettori una sua personale valutazione dell’attuale stato di salute del settore del vino?
Vedo indubbiamente una situazione di stasi che a mio parere ha diverse concause: il fatto che le giovani generazioni bevano meno vino è certamente vero, ma è solo una parte del problema. Stiamo vivendo l’onda lunga del periodo Covid, con una sensibilità molto forte nei confronti degli aspetti salutistici: cibo e vino ne risentono moltissimo. La situazione economica, poi, induce alla prudenza e, anche dove c’è disponibilità di spesa, si assiste a comportamenti cauti.
Le cantine medio-piccole, che costituiscono l’ossatura del tessuto vitivinicolo italiano, sono da anni in lotta per l’equilibrio di bilancio e si reggono fondamentalmente sulla loro natura familiare: se si contassero anche i costi indiretti, figurativi, e quindi se si dovesse remunerare anche il lavoro interno, i conti delle aziende sarebbero ancora più in rosso. Se sparissero i contributi pubblici vedremmo effetti ben più gravi di quelli attuali. C’è da domandarsi come mai non sono molti di più gli imprenditori che cedono i propri asset. Le aziende di piccole dimensioni non hanno accesso a managerialità, a economie di scala, a investimenti strategici come quelli in comunicazione: questo le espone a sensibili rischi di sopravvivenza.
La maggior parte delle cantine italiane fa fondamentalmente fatica ad adattarsi alle sfide tecnologiche: il mio non è un giudizio, mi limito a prendere atto di una situazione. Mancando la managerialità non c’è modo di affrontare seriamente una digitalizzazione produttiva e comunicativa: oggi un comunicatore deve conquistare il consumatore in 5 secondi, non in 5 minuti, deve essere immediato, leggero e digitalizzato.
Le aziende di piccole dimensioni non sono pronte ad affrontare le grandi prove imposte dal cambiamento climatico: non hanno la libertà di manovra dei grandi gruppi e non possono decidere di diversificare vitigni, altitudini, di riconvertire linee di prodotto. E non hanno neanche la mentalità per farlo. Sono legate al concetto di tradizione e non hanno la capacità di rileggerla in modo innovativo. Questo è un altro aspetto che spiazza molto la cantina media italiana.
Quali sono gli errori più grandi che il marketing del vino compie in questi anni?
Credo che non si stia tenendo in debito conto che il mercato è fatto per l’80% da consumatori che sono potenzialmente attratti dal vino di qualità, ma non vogliono necessariamente conoscere ogni dettaglio tecnico e produttivo. Il mass-market non ama la seriosità del vino e non vuole sentirsi in dovere di comprenderne i tecnicismi. Se le aziende medio-piccole continuano a puntare solo sul 20% del mercato sofisticato, impegnato e colto continueranno ad avere difficoltà di mercato.
Non sto dicendo che la maggior parte dei bevitori di vino ama il vino nel cartone; al contrario, ama la qualità, ma ha un concetto di qualità che non si riconosce nello sforzo celebrativo del vino, che invece prevale nella comunicazione attuale. Credo che tutti noi operatori dovremmo smettere di guardare con snobismo a questa fascia di consumo, che è la più grande.
C’è un grande bisogno di alleggerire la comunicazione, di smetterla di pensare che il vino debba sempre essere al centro della conversazione conviviale. C’è bisogno di pensare che la maggior parte delle persone desidera bere un bicchiere di vino in allegria, serenità e relax. Il food soffre molto meno di questo problema.
La qualità percepita è molto distante dalla qualità “tecnica” che hanno in mente le aziende: solo una piccola parte del mercato è in grado di percepirla, mentre per tutto il resto dei consumatori la qualità risponde ad altri valori, che sono quelli che muovono le scelte di acquisto. I motivi per cui si compra un vino possono essere molteplici, spesso non legati alla “qualità” del liquido dentro la bottiglia.
Tiriamo dentro altre fasce di consumatori, non rivolgiamoci sempre agli stessi! E trasmettiamo messaggi che le persone sono pronte ad accogliere.
Questo vale anche per l’enoturismo, che è spesso monotono e noioso: l’attenzione è rivolta agli intenditori, ma diciamocelo, un’esperienza in cantina che tocchi soltanto gli aspetti tecnici della produzione, è quasi sempre uguale a sé stessa.
Questo vale per il mercato italiano oppure per il mercato internazionale?
Il concetto che esprimo è assolutamente globale. Se guardiamo per esempio al mercato USA, ci rendiamo conto di quanto questo sia vero. La maggior parte delle cantine che vuole affrontare il mercato americano si rivolge alla clientela alto-spendente, di età medio-alta, che ha tempo e risorse economiche da dedicare al vino, che ha la cultura per comprenderlo. Ma negli Stati Uniti stanno tirando venti diversi in questo momento: c’è una grande richiesta di vini low e no alcohol; ma c’è anche un bisogno di leggerezza, di non prendersi sul serio. C’è tanto mercato da raggiungere negli USA, ma il produttore che non si mette in gioco dal punto di vista comunicativo ha enormi difficoltà a raggiungerlo.
È chiaro che poi ogni Paese ha le sue criticità. Avete citato il mercato cinese: per esperienza diretta, avendo vissuto in Cina diversi anni, ho un’opinione piuttosto tranchant al riguardo. Se fino al 2017 la piazza cinese, sostenuta anche dal Governo locale, investiva direttamente sul vino, acquisendo professionalità dall’estero, costruendo nuove cantine e in generale dimostrando grande interesse per il settore, oggi puntare sul mercato cinese è a mio parere molto rischioso. Dobbiamo accettare che non ha senso attendere l’occidentalizzazione della Cina. L’esperienza del vino australiano ci ha insegnato che da un giorno all’altro le cose posso cambiare in modo imprevedibile.
Sul fronte produttivo crede che le aziende debbano mantenere l’identità del prodotto ad ogni costo oppure dovrebbero provare ad avvicinare il prodotto ai trend di consumo?
Non credo sia necessario né d’altro canto possibile stravolgere la propria produzione. Sono convinto però che le aziende debbano mostrare sensibilità a tutti gli accorgimenti che siano in grado di avvicinare la propria offerta a ciò che il mercato chiede: se ciò significa, per esempio, agire sulla gradazione zuccherina di uno spumante, non vedo ostacoli nel farlo. Se parliamo però di connotati che distinguono una tipologia di vino in modo identitario, come nel caso di un Amarone, per esempio, non penso abbia senso mettere in discussione la quantità di alcol e la struttura del vino, salvo piccoli aggiustamenti.
Torno sul motivo conduttore di tutte queste mie riflessioni: penso che sia più importante e più fattibile cambiare il modo di comunicare un vino, piuttosto che modificarne gli aspetti produttivi.
Key point
- Superare il tecnicismo del vino
- Sfide economiche e strutturali delle piccole cantine
- Percezione della qualità e comunicazione nel mercato globale