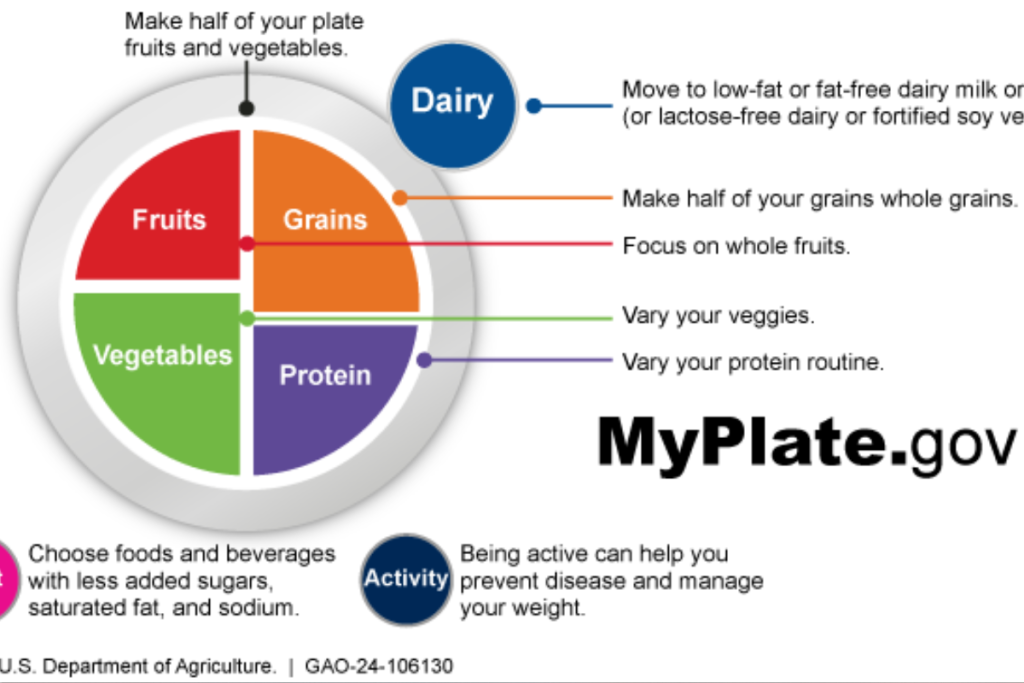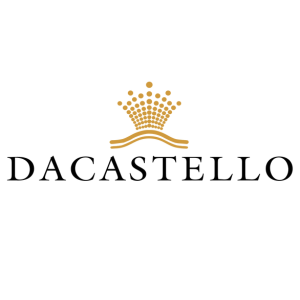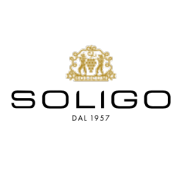Antonio Bonotto, diciannovesima generazione della famiglia Bonotto dalle Tezze, racconta la sua storia legata al Raboso Piave e alla memoria vitivinicola. Un viaggio tra tradizione e innovazione, dall’eredità familiare alla valorizzazione del Raboso, passando per il ruolo della cultura e del territorio nella crescita aziendale. Un ritratto di passione, impegno e visione.
Non hai antenati nel vitivinicolo? Cercali! Fossero anche parentele lontane, acquisite.
Se non vanti avi vigneron di chiara fama, lontani nel tempo e nello spazio e non hai una storia di famiglia che affondi radici almeno nel medioevo o giù di lì, come imprenditore vitivinicolo non sei nessuno. Ti manca uno storytelling adeguato e funzionale da dispensare a clienti, winelover, comunicatori o giornalisti che siano.
Il buon manuale del “vignaiuolo meraviglioso” elenca da anni gli aspetti che non possono mancare alla narrazione aziendale vincente: storia, tradizione, blasone, se non sangue blu, su tutti. Sarà!
Eppure, tra i tanti produttori che hanno sperperato fortune tra araldisti e genealogisti, quelli che una storia vera, secolare, lineare ce l’hanno non mancano. E spesso l’hanno ereditata con naturalezza, senza volerne fare per forza un elemento distintivo o di eccezionalità, di lignaggio se non di nobiltà acquisita, consapevoli della responsabilità di possedere un bagaglio di storia da preservare e da donare ai posteri come uno scrigno di preziosi.
Se c’è un produttore in Veneto che risponde a quest’ultima categoria questo è sicuramente Antonio Bonotto, diciannovesima generazione documentata dei Bonotto dalle Tezze, piccola frazione in comune di Vazzola nel trevigiano. Terre della Piave, come si usa chiamare da queste parti il fiume “sacro alla Patria” teatro di alcune tra le più acerrime battaglie della Grande Guerra.
E terre del Raboso, non a caso conosciuto come Raboso Piave. Un vitigno storico, se non autoctono, noto ai più per il suo carattere forte, resistente, spigoloso; qualcuno addirittura arriva a definirlo indomabile, difficile da ammansire, a fronte di caratteristiche varietali in grado di portare in vasca un carico di acidità e di tannicità come pochi altri.
Negli ultimi decenni alcuni viticoltori si sono spesi per recuperarne la storia, a partire dal classico sistema di allevamento alla “bellussera”, e per valorizzarne il giusto utilizzo così da ottenerne un vino buono e identitario con una collocazione adeguata sui mercati. Pochi, visionari, irriducibili templari del Raboso tra i quali l’indiscusso, compianto Giorgio Cecchetto venuto a mancare pochi anni fa.
Antonio Bonotto, filosofo mancato, agronomo illuminato e viticoltore per ineluttabile destino è un passatista convinto nella sua accezione più alta: la storia è maestra di vita ed è destinata a ripetersi, talvolta come farsa. E con questa veste, che talvolta gli attira i rimbrotti di moglie e figli perché non butterebbe via neanche il più inutile, vecchio chiodo arrugginito dimenticato a fondo cantina, mette in fila tutti i ricordi che da sempre lo aiutano a rischiarare l’orizzonte e ad avere una visione più nitida e definita del futuro.
Il primo e più appassionato, addolorato ricordo lo riserva, appunto, a Giorgio, collega e maestro. “La nostra area – sottolinea Antonio – ha perso la figura più simbolica. Quella che si è spesa di più nella viticoltura e in particolare nel recupero e rilancio del Raboso. La sua mancanza è un vuoto che si vive quotidianamente nonostante i suoi figli gli stiano più che degnamente succedendo. E mi sento quasi un usurpatore ad essere parte di questo racconto e a dare rappresentanza, senza meriti, a quest’area produttiva, perché lui ha fatto un percorso lineare, inappuntabile, appassionato sin dalle scuole superiori nel mentre io cazzeggiavo nei miei sogni di peripatetico, quarto di cinque figli che prima di me avrebbero potuto portare avanti l’azienda di papà Luigi e mamma Giulia. Da ragazzo frequentavo il liceo scientifico di Conegliano (Tv) e tra tutte le materie apprezzavo in particolare quelle umanistiche tanto è vero che guardando all’università volevo iscrivermi alla facoltà di Filosofia. Alla fine, invece, mi sono trovato studiare e a laurearmi in Agraria”.
Non che Antonio sia arrivato al mondo del vino da cittadino qualunque considerato che già all’età di sette anni guidava il trattore che conduceva il carro dei vendemmiatori della Bellussera. “E guardavo con un senso di invidia l’altro carro trainato dal cavallo, carico di giovani coetanei dei mei fratelli che scherzavano, suonavano e cantavano mentre nel mio barroccio c’erano nonni e nonne e un vocio dimesso, operoso, quasi mistico. Guidavo questo vecchio Ferguson degli anni quaranta e ascoltavo questi racconti di anziani che adesso pagherei oro per sentire ancora ed apprezzare appieno. Atmosfere e tradizioni di vendemmia che si sono perse nel tempo. C’erano personaggi come il cosiddetto “Sacrestano” che era affetto da grave sordità e quando ci si rivolgeva a lui bisognava urlare. Non ha mai avuto l’orologio ma, non si sa come, quando le campane distanti due chilometri battevano mezzogiorno le sentiva subito. Era sintonizzato sulle onde sonore del campanile con particolare sensibilità verso l’ora in cui ci si metteva a mangiare e bere. Nella borsa sgualcita giravano bottiglioni da due litri di rosso e poi si, poca ma c’era anche l’acqua”.
La Storia, e che storia
Dal 1420, la famiglia Bonotto dalle Tezze ha attraversato numerose generazioni. “Capire le radici profonde che ci uniscono e quanto pesi la responsabilità di essere un punto di riferimento storico per questa terra non è affatto semplice. Per noi, non si tratta solo di racconti, ma di una storia vissuta e condivisa: gli influssi e le relazioni con gli Ordini Monastici, il dominio della Serenissima, le prime innovazioni nella viticoltura, la nascita della Scuola di Enologia di Conegliano e tanti altri avvenimenti legati a un lungo passato. Le prime tracce della famiglia Bonotto in Veneto – e in particolare a Tezze – risalgono al XV secolo, quando si cominciò ad assegnare un cognome alle famiglie e a delineare i casati. Il nome Bonus si trasformò in “Bonotus” e, successivamente, in Bonotto, che significa “buono” o “fortunato”. Fin dalle prime testimonianze documentate, la famiglia Bonotto dalle Tezze si è dedicata con costanza all’agricoltura e al commercio dei suoi prodotti. E il vino, in particolare il Raboso del Piave, ha sempre rappresentato un simbolo di questa tradizione”. Venendo ai giorni nostri, dal padre Luigi, Antonio ha ereditato l’attenzione al sociale, alla comunità. Liberale di principi ma socialista nei fatti, Luigi si impegnò in politica fino al punto da accettare la candidatura al Parlamento nel 1963 col Partito Liberale mancando l’elezione per una settantina di voti. E nonostante non fosse mai stato democristiano godeva di tale autorevolezza da poter frequentare tutti i notabili DC dell’epoca per dirimere le problematiche dell’agricoltura, in un territorio dove la balena bianca raccoglieva oltre l’ottanta per cento dei consensi. “Lui viveva per far crescere il benessere nelle campagne e si impegnò molto nelle categorie professionali e nel mondo della cooperazione agricola. È stato per molti anni presidente del Consorzio di Bonifica, membro di giunta della Camera di Commercio, consigliere della Cassa di Risparmio della Marca Trevigiana, com’era chiamata allora. Talmente integerrimo e ligio ai suoi doveri che, ricordo, volle partecipare a tutti i costi al suo ultimo consiglio della Cantina Sociale di Tezze da presidente in carica da ventiquattro anni. Ha salutato e stretto la mano, uno per uno, a tutti i consiglieri ed è morto dopo dieci giorni. Oggi la consideriamo in maniera diversa ma tra gli anni sessanta e novanta la Cantina Sociale di Tezze era una delle più importanti del Veneto”.
Quando è mancato Luigi nel 1997, Antonio conduceva l’azienda da sei anni. “All’epoca avevo poche idee e ben confuse, come si dice, e non grandissime risorse economiche, ma la cosa certa è che volevo provare a valorizzare quello che avevamo in disponibilità e coltivavo il sogno di arrivare a produrre un grande vino. Non ho mai ceduto un centimetro delle nostre proprietà e se ci sono riuscito lo devo soprattutto al forte attaccamento a tutto ciò che dalla storia mi era arrivato. Negli ultimi dieci anni il lavoro sviluppato grazie all’uva glera e al successo del Prosecco, ha permesso a tanti produttori come me che hanno reinvestito in azienda ogni centesimo, di crescere e di ottenere una rimunerazione idonea a realizzare progetti che altrimenti rischiavano di rimanere solo sogni”.
In tutto questo vissuto, la presenza discreta ma determinata di mamma Giulia è stata un punto di riferimento e di equilibrio imprescindibile per la famiglia. È mancata quattro anni fa. Giulia era figlia di una ostessa perché sua mamma aveva un’osteria a Cimadolmo e ne aveva ereditato il senso del commercio e una visione lucida sulla modernità. “È stata maestra ed ha sposato un uomo bello, istruito, mediamente ricco e ci ha fatto cinque figli. Era felice quando arrivavano i clienti e acquistavano i cartoni di vino”.
Il dovere innanzitutto
Complessivamente, anno dopo anno, Antonio ha vissuto l’azienda di famiglia come un dovere, una responsabilità percepita fin da subito, ma senza avere un orizzonte professionale o aziendale definito. Un’azienda agricola che sessant’anni fa conduceva 90 ettari di cui 18 a vigneto ma che di imprenditoriale aveva poco: imperniata sulla mezzadria, aveva una parte dedicata all’allevamento, terreni destinati a seminativo e dopo, ma solo dopo, anche la vite.
“Così l’aveva impostata mio padre che era rimasto orfano di nonno Giovanni a sedici anni e costretto, per questo, a guidare l’azienda e a studiare allo stesso tempo fino alla laurea in agraria a Bologna nel 1947”. Ma a Luigi la sola gestione dell’attività di famiglia sarebbe risultata stretta tanto è vero che ha dedicato la sua vita allo sviluppo sociale e culturale della comunità. “Da bambino – ricorda Antonio – ho frequentato le elementari a Tezze e poi le medie inferiori a Conegliano, non a Vazzola. Appena arrivato dal paesello i professori mi chiesero chi fossi e da dove venissi. Dovevo dire che mio padre faceva l’agricoltore, una professione che a Conegliano, così come un po’ in tutte le cittadine dell’epoca, veniva equiparata all’ultimo gradino della scala sociale, vino, latte o cereali che si producesse. I figli degli operai della Zoppas, tanto per dire, davano la sensazione di essere più contemporanei, più considerati e accettati socialmente. Più fighi! Bene, io sono figlio di questo momento storico per cui non era facile trovare la chiave per prendere e ridare slancio all’azienda affascinato com’ero dalle idee dell’umanesimo, sicuramente più romantiche e coinvolgenti. Non era un ambiente confortevole o che attirasse la mia curiosità e i miei interessi quello della viticoltura e del vino nella nostra azienda. Sembrava un mondo sostanzialmente ripetitivo, dimesso, quasi in disarmo (lo scandalo del metanolo risale proprio a quel periodo): sempre gli stessi vigneti, stesse varietà, gli stessi metodi e i vini pure. Mio padre stesso aveva negli ultimi anni indirizzato e gestito l’azienda come dovesse andare avanti per sempre allo stesso modo, investimenti minimi per non dire assenti. Terminati gli studi superiori ho continuato ad interessarmi di filosofia anche se poi una borsa di studio biennale presso l’allora istituto Sperimentale per la Viticoltura di Conegliano mi ha fatto riassaporare la materia agraria”.
Luigi ha fatto di tutto per evitare che Antonio subentrasse nella gestione dell’azienda tanto era convinto che con la sola attività agricola non si sarebbe mai riusciti a mantenere una famiglia. Lui l’ha mantenuta facendo altro e avendo le spalle larghe da figlio unico e laureato dell’epoca. “Una grossa delusione che ho dato a mio padre – sottolinea Antonio – è stata quella di non superare il concorso per diventare professore alla Scuola Enologica nonostante avessi superato gli scritti. Nella sua testa questo significava aver potuto disporre di uno stipendio sicuro mentre temeva che la conduzione dell’azienda non garantisse una sufficiente redditività se non vissuta con i criteri del diretto coltivatore, ruolo in cui ovviamente non mi ci vedeva e non mi ci voleva. Essendo lui un signore di cultura che conosceva greco e latino non era certo attratto da alcuni aspetti un po’ grevi che venivano dalle nuove generazioni della proprietà contadina. Aveva amato quel mondo cui aveva dedicato le migliori capacità ed energie, ma aveva anche capito come tanti valori come rispetto, onore e amicizia stavano un po’ sparendo dalle campagne. Ricordava spesso che quando erano arrivate le prime trebbie in azienda le mogli dei braccianti si erano distese lungo la strada di accesso ai campi per non farle passare per paura di perdere il lavoro. Era figlio di queste esperienze che in qualche modo pare anche a me di aver interiorizzato al punto tale da sentire di dover rinunciare a perseguire il meglio quando questo possa in qualche modo essere nemico del bene”.
Ma… “le strade portano sempre a un destino più che ad una destinazione”, scrisse Jules Verne, e Antonio nel 1990 prese in mano le redini dell’azienda. “Dissi a mio padre che mi sarei arrangiato nella conduzione dell’azienda e ho cercato di tranquillizzarlo cercando di garantire sostenibilità economica utilizzando i mezzi e le forze disponibili. Non che non avessi bisogno di aiuto ma semplicemente cercavo di fare il possibile lavorando dodici ore al giorno e senza conoscere sabati, domeniche e festività. Succede che anche in quel momento finisco per essere condizionato da tutta questa smania di conservazione di oggetti e orpelli del passato dei quali custodire morbosamente memoria. Avevamo una cantina che oggi definiremo ancestrale, piena di oggetti che oggi fanno tendenza come torchi, vecchie ceste, ecc. E facevamo ancora i bianchi in macerazione, senza frigoriferi con il controllo delle temperature affidato a qualche serpentina di acqua del pozzo. Quando mi sono convinto di produrre vino con una visione più imprenditoriale e commerciale, mi sono affidato ad enologi ed esperti che mio padre conosceva e stimava. Purtroppo, però, hanno sbagliato l’approccio. Dal loro punto di vista bisognava buttare via tutto perché non c’era niente in quella cantina che meritasse essere mantenuto. Ma parlavano di quella stessa cantina che io vedevo quasi come una sorta di tempio sacro. Vasche di cemento quasi secolari, corridoi di botti, vecchie pompe a pistoni, e così via. Ho dovuto aspettare un po’ finché ho trovato una persona intelligente che mi ha fatto fare un’evoluzione tecnica graduale rispettando e condividendo la mia sensibilità”.
Gli esordi sono stati tutt’altro che semplici perché i progetti, i sogni, le ambizioni nel mondo della vite e del vino devono coniugarsi in primis con un fattore essenziale, il tempo. E quella è la prima fondamentale lezione che si impara. A credere, a non mollare, a tenere duro perché il risultato lo vedrai al giusto tempo. “Ma l’attesa ti ripaga perché ti dà gli strumenti per assaporare appieno, poi, la soddisfazione del percorso, motivo per cui non mi sono mai pentito di aver fatto questa scelta, anzi. Anche perché di mio ho sempre cercato di vivere bene il momento, anche quello delle difficoltà, delle rinunce. E questo è stato agevolato dall’aver conosciuto e poi sposato mia moglie Vittoria una vera super vincita alla lotteria. Una figura che non proveniva da questo paese e da questo mondo ma che lo ha amato e interpretato nel migliore dei modi. Non mi ha mai fatto pesare i momenti delle preoccupazioni e delle rinunce quando ancora eravamo lontani dall’enfasi e dai risultati dei vini di oggi. D’altronde, l’obiettivo principale era quello di costruire un’economia familiare adeguata a garantire pienamente tutti gli studi ai figli. Non mi sono mai appassionato al possesso ma solo al percorso cercando di vivere al meglio ogni momento. E alla fine posso dirlo: altro che staticità e ambiente ripetitivo! Questo è un mondo avvincente, stimolante, pieno di tutto”.
Il peso della memoria
Guidato da un grande senso della memoria e rispetto per quanto di prezioso arriva dal passato, Antonio ha sempre voluto conservare tutto, dal semplice pezzo di carta all’attrezzo da lavoro, custodito gelosamente tra le prese in giro benevole dei familiari.
E non solo oggetti o documenti di stretta proprietà, ma anche fascicoli recuperati nei granai di vecchie case coloniche disastrate dai bombardamenti della prima guerra mondiale. “Non mi definirei un passatista che ama circondarsi di feticci o orpelli inutili, ma resto convinto si possa capire ed apprezzare completamente chi siamo se sappiamo da dove siamo venuti. L’uomo è come l’albero, può cambiare le foglie, non le radici. Ma per trarne insegnamento deve conoscerle e comprenderle. Ogni epoca è diversa ed io cerco di vivere il presente e di immaginare il futuro ma sempre indagando il passato. Questo è positivo dal mio punto di vista ma limitante nel momento in cui ci si trova a dover intraprendere e accompagnare il passaggio generazionale aziendale ai figli, dovendo abbracciare fino in fondo la modernità: un orizzonte agronomico, vitivinicolo, manageriale nuovo e aggiornato alla luce dei tempi che rischia di essere contaminato da una visione, la mia, inevitabilmente vecchia e in parte superata sulle modalità di allevamento delle uve, sugli stili dei vini, sulle etichette, ecc. Un bel problema! Tanto per fare un esempio, nella vecchia cantina c’erano i bottoni di Raboso di cui ricordo distintamente i profumi. Quando mio figlio Luigi mi dice che è ora di procedere con i tagli finali tra Rabosi provenienti da botte, da barrique, da tonneaux ecc., per poi metterli in bottiglia, se non sento quell’aroma così nitido nella mia memoria olfattiva ho la sensazione che manchi qualcosa di importante. Capisco che questo approccio potrebbe essere limitante per la “bottega” ma fa parte del mio bagaglio culturale ed esistenziale. E allora, tutto considerato, alla fine mi convinco che il tema enorme da affrontare nell’immaginare e pianificare la vitivinicoltura del futuro sia quello di attualizzare la storia, la tradizione, prendendo quanto di buono abbiamo fatto e imparato nei secoli. Penso, ad esempio, alla storia del Raboso che racconto a clienti e winelovers di passaggio cercando di far capire innanzitutto quanto il sistema di coltivazione alla Bellussera, che oggi sembra un retaggio abbandonato del passato, sia stata in realtà un’innovazione ingegneristica e di intelletto incredibile per il periodo; una modalità tutto sommato recente di allevamento, durata 120 anni nei 2000 e più di storia della viticoltura di questa zona, ostacolata da molti soloni dell’agronomia dell’epoca e che invece è stata determinante nell’evoluzione delle piantate alla veneta e nell’economia delle nostre campagne. E ancora oggi ha il suo perché e potrebbe risultare avveniristica considerati gli effetti del cambiamento climatico”.
Un aneddoto che Antonio ama ricordare, tornando ai bottoni, riguarda ancora Giorgio Cecchetto che volendo concretizzare il suo progetto sul Raboso andava ad assaggiare le botti di Luigi Bonotto nei primi anni ottanta. “Io capivo che lui era oltre, che guardava avanti e che le chiavi di lettura sue erano il triplo delle mie. Stava già cercando di trovare e consolidare un punto di partenza per costruire il futuro di questo vitigno e per questo gli dobbiamo riconoscenza. Mi piace pensare che quegli assaggi siano stati importanti per lui anche perché pochissimi negli anni ottanta, spesso solo le cantine nobiliari, facevano invecchiare il Raboso. Se Giorgio non avesse trovato queste vecchie botti forse non si sarebbe appassionato e convinto a imboccare il percorso di riscoperta e rilancio del Raboso? Rimane una piacevole suggestione”.
La modernità del Raboso. La concretezza del Prosecco.
“Una cosa che ha caratterizzato il mio percorso è forse il fatto di non essere enologo avendo così avuto modo di riempire d’altro il vuoto che questo determina. Sono e mi sento un agronomo e, come tale cerco di mantenere un approccio scientifico alla gestione dei vigneti. La base è produrre uva sana e di alta qualità poi in cantina c’è spazio per le diverse interpretazioni. In questo senso nutro forti perplessità sulla coltivazione biologica in questo nostro ambiente anche se capisco che questo consenta di occupare mercati e creare economie che in caso contrario lasceremmo ad altre zone. Pensiamo che i primi rapporti sulla gestione guidata dei trattamenti fitosanitari sono degli inizi degli anni ottanta quando la provincia di Treviso aveva già un manuale di lotta integrata. Ciò dimostra da quanto il mondo agricolo professionale abbia affrontato questi temi così delicati e importanti. Fondamentalmente credo molto di più ad una viticoltura guidata da tutte le conoscenze che la scienza e la tecnologia mettono a disposizione rispetto a chi si prende la patente green per il fatto di seguire un protocollo biologico. Il problema della difesa fitosanitaria in un territorio di viticoltura intensiva e fortemente urbanizzato è un tema importantissimo, ma non penso si risolva applicando i protocolli di un secolo e mezzo fa. Io, paradossalmente, uso alghe e tanti altri prodotti biologici ma non inseguo la certificazione per poter utilizzare le indicazioni più attuali e innovative della ricerca e della tecnica, per fare le cose come si deve e quando serve, senza inquinare, per il bene della vite, del vino e del consumatore. C’è tanta confusione ma per quanto mi riguarda ci vuole il giusto atteggiamento, scientifico, fatto di buone prassi agronomiche e calibrato sulle caratteristiche e le vocazioni dei territori. Da questo punto di vista, se proprio si pensa a qualcosa di più naturale mi convincono di più i colleghi che applicano la biodinamica e che ne accettano i rischi. Per quanto riguarda il vino trovo interessante l’approccio di un non enologo, come nel mio caso: poter fare, provare, sbagliare senza troppi preconcetti. Se uno guarda al portafoglio è evidente che se invece di intestardirmi a fare il grande rosso avessi fatto scelte più speculative, l’azienda sarebbe oggi più florida. Ma in fin dei conti il percorso che costruisci devi sentirlo tuo come nelle scelte tecniche dove ho spesso fatto di testa mia: se tutti prendevano una determinata pressa a me invece piaceva spaziare e vederne e magari acquistarne altre. Mi sono sempre fatto guidare molto dall’istinto che da un punto di vista strettamente tecnico può risultare limitante se non sbagliato; ma, come detto, non sarebbe stato il mio percorso. Nel tempo ho cercato di costruire un’azienda equilibrata senza scendere a compromessi, senza abbandonare gli insegnamenti del passato e con la giusta dose di umiltà. In fin dei conti mi sento figlio di tante cose non certo della banalizzazione di un mestiere che ritengo debba essere vissuto con nobiltà”.
Antonio ci ha messo cinque anni prima di poter assumere personale e ampliare la superficie vitata per un’azienda che col tempo ha raggiunto gli ottanta ettari tra terreni in proprietà ed affitto di cui venticinque destinati a Glera per la produzione di basi spumanti e qualche bottiglia di Prosecco e una buona produzione di Pinot Grigio. “Abbiamo cercato un equilibrio tra la giusta redditività garantita dalle varietà trainanti e fruttuose e una produzione sartoriale fatta di vini di nicchia derivati, tra le altre, da uve Raboso, Carmenere, Incrocio Manzoni 6.0.13 e Grapariol. Il Raboso, in particolare, mi stimola perché significa lavorare con una materia prima che proviene dal passato remoto e che, insieme agli abitanti, ha saputo evolvere per adattarsi ai tempi che mutavano. Sicuramente in epoca romana ma di certo ai tempi della Repubblica di Venezia che per 500 anni ha dominato i commerci del Mediterraneo e lo utilizzava come “vin da viajo” (vino da viaggio) nelle missioni verso Oriente. Noi nei sistemi di allevamento e produzione, in particolare del Raboso, suffragati da conoscenze e tecniche contemporanee, stiamo tornando indietro come approccio a quando non si irrigava, a quando si concimava con lo stallatico, a quando le rese non erano troppo spinte. Insomma, stiamo tornando alla viticoltura più vicina a quella che è stata storicamente fino agli anni cinquanta e sessanta del novecento. E in cantina possiamo disporre di nuove possibilità. Ai tempi di mio padre, tanto per dire, una fermentazione malolattica al Raboso non si faceva fare ma neanche si pensava fosse possibile. Trovo grande attualità e modernità nel Raboso Piave quasi fosse un vitigno selezionato per la viticoltura di adesso: accumula tannino, zuccheri, ma mantiene un’acidità importante anche a piena maturazione. L’acidità è un patrimonio, oggi ancor più prezioso se pensiamo ai cambiamenti climatici e commerciali, dove la freschezza e la verticalità dei vini è tanto ricercata quanto minacciata dalle estati sempre più torride cui siamo sempre più abituati. Certo non possiamo proporre una limonata ma puntare ad utilizzare la spalla acida cosiddetta come un grande valore aggiunto su un vino che dopo anni mantiene una beva e un’integrità e succosità e croccantezza del frutto incredibili. Il paradosso è che per dare risposta alle attuali problematiche si pensa a modificare la genetica dei vitigni e non si usano quelli che già abbiamo, come il Raboso Piave, che potrebbero essere ottimi interpreti di questa fase di riscaldamento globale. Capire come una cosa che viene dal passato possa interpretare presente e futuro è affascinante. Emblematico a questo proposito il Metodo Classico, Luigi Venti, cento per cento da uve Raboso che mio figlio Luigi presenta quest’anno e che io considero come simbolo del rinnovamento di prodotto e di azienda considerato come in tutti questi anni essa sia stata identificata dai nostri clienti con l’etichetta Potestà, un Raboso Piave DOC, tradizionalmente inteso come vino di lungo invecchiamento. Ci sarà ancora da lavorare sulla nobiltà del prodotto ma credo che questo vitigno, reinterpretato alla luce dei tempi e delle conoscenze, possa avere un gran futuro”.
La glera? Un vitigno storico e nostrano che con la denominazione Prosecco gioca e vince nel campionato del mondo è per Antonio una conquista grandiosa e destinata a restare. “Nei decenni il Prosecco potrebbe perdere posizioni e competitività nelle fasce di mercato border line. Tuttavia, ci sono tantissimi possibili nuovi mercati e clienti che potremo raggiungere considerate le tante aree dove non è ancora arrivato semplicemente perché non ci si è ancora proposti in maniera organizzata e sistematica come per altre zone. Credo che negli anni ci sarà una qualificazione del mercato con anche un aumento del numero di bottiglie vendute nel mondo. Ma se ci sediamo sugli allori senza evolvere e ricercare una qualità ancora maggiore, senza sforzarci di formare e educare vecchi e nuovi consumatori, potremmo incontrare delle difficoltà. Non credo succederà”.
Restituire qualcosa
“Siamo arrivati fino a qui ma questo non vuol dire che ci siano certezze. Vediamo cambiamenti epocali avvenire in lassi di tempo molto ristretti, non solo nelle tecnologie ma anche nei prodotti e nei commerci. Le recenti norme sui vini low e no-alcol ne sono un esempio. Potrà la cantina artigianale avere ancora un senso, un ruolo, una dignità in futuro con un mondo del vino destinato a rispondere sempre più a logiche industriali o addirittura finanziarie? Non si sa e comunque a noi non resta che dare il massimo giorno per giorno per realizzare i nostri sogni o progetti. Indubbiamente la nostra azienda è un’azienda storica di una famiglia storica inserita in un contesto storico. Ma questo costituisce solo il punto di partenza per attuare i necessari cambiamenti. Il fatto che sia ubicata nella piazza del paese contribuisce a evidenziare la necessità di interazione con il paese e la comunità che lo vive. La nostra è una cantina nata per essere luogo di scambio, di interazione, senza per questo dimenticare che i conti devono tornare. Spero di riuscire a trasmettere ai miei successori la convinzione che la cantina deve e dovrà essere un posto per tutti, aperto alle contaminazioni culturali, anche alle provocazioni e agli squarci in quella che potrebbe essere considerata colpevolmente una “confort zone” come si dice oggi, nell’interesse dell’azienda stessa, della famiglia e della comunità intera. Il tutto in un’epoca in cui anche nei piccoli paesi di campagna sono in atto veri e propri stravolgimenti nella vita, negli usi, nelle consuetudini e nei rapporti interpersonali. L’azienda agricola non è delocalizzabile e utilizza nei mercati di tutto il mondo la denominazione territoriale, per dare maggior valore alle proprie etichette, ragion per cui dovrebbe essere naturale per il nostro settore, ma non sempre lo è, avere in mente il concetto di restituzione. Si può intervenire al sostegno di enti benefici o in aiuto al disagio, o al mondo dello sport o altro ancora. Noi abbiamo sempre creduto all’importanza dell’aspetto culturale per aspirare a relazioni virtuose, partendo dai bambini delle scuole d’infanzia spesso da noi sollecitati e coinvolti nelle nostre iniziative. Da loro si parte per dare un contributo concreto seppur piccolo nel provare a costruire una forma mentis più portata a cercare il senso delle interazioni tra individuo, gruppo e società, a incidere sulle singole azioni e sviscerarne gli aspetti filosofici e sociali, per la ricerca del senso delle cose, per la storia, per la salvaguardia della memoria e per l’amore del dialogo tra contemporaneo e antico, In questo senso, oltre a promuovere e organizzare da anni innumerevoli occasioni di incontro culturale, di musica, teatro, letteratura, saggistica, poesia, finanche di costume e tradizione e, perché no, conviviale eno-gastronomica, abbiamo da alcuni anni investito molte risorse in un progetto di residenza artistica professionale, dotato di curatore, direttore artistico e ufficio stampa. Officina Malanotte è giunta alla quarta edizione totalmente sostenuta dalla nostra azienda. Per un mese artisti italiani e internazionali vivono e lavorano negli spazi dell’azienda e del paese intero con il quale entrano in relazione fisica e culturale. Paradossalmente non hanno l’obbligo di produrre arte, anche se l’esperienza si conclude con un Open Studio, quanto di conoscere e condividere le persone e i luoghi, non ultime le botteghe e le osterie, ovviamente. Mecenatismo puro potrebbe essere definito mentre credo sia solo un modo di attualizzare l’idea di provare ad arricchire in qualche modo le nuove dinamiche sociali in un piccolo paese della campagna trevigiana, considerato di logica totalmente estraneo ai classici itinerari dell’arte contemporanea. A me interessa che le persone del paese e gli artisti interagiscano e che quando se ne vanno via gli rimanga qualcosa di un luogo che nel frattempo ha avuto modo di raccontarsi e tenere vive le sue memorie, le sue peculiarità.
Mi trovo a mio agio in questi ambiti “paraenologici” di progettazione culturale e attivismo sociale. E mi piace soffermarmi sul contributo dato dai miei avi, da mio nonno e da mio padre alla comunità rispetto allo sviluppo dell’agricoltura, dell’enologia, e nella salvaguardia della memoria collettiva. Il mio apporto? Il mio lascito? Chi lo sa! Se non altro, insieme ad altri produttori, col Raboso abbiamo provato a salvare e a rilanciare un vitigno storico. Se non ci fossimo stati noi i nostri figli il Raboso forse non lo avrebbero mai conosciuto e magari sarebbe anche sparito dalle tavole dei ristoranti. Oggi invece nascono nuove etichette e interpretazioni, come il Metodo Classico. Coltiviamo con grande dedizione sette ettari a Raboso e non è poco”.
Punti chiave
- Antonio Bonotto, agronomo e viticoltore, porta avanti la memoria familiare e la valorizzazione del Raboso Piave.
- Il Raboso Piave è un vitigno storico, resiliente e di grande potenziale per affrontare il cambiamento climatico.
- L’azienda Bonotto integra tradizione e innovazione, mantenendo la memoria del passato e adattandosi ai nuovi mercati.
- La cultura e il territorio sono al centro della filosofia aziendale, con iniziative come Officina Malanotte.
- Il Prosecco è il motore economico, mentre il Raboso è il simbolo identitario della famiglia e del territorio.
FAQ – Frequently Asked Questions
1. Chi è Antonio Bonotto e qual è il suo legame con il Raboso Piave?
Antonio Bonotto è un viticoltore veneto della diciannovesima generazione della famiglia Bonotto dalle Tezze, noto per la valorizzazione del Raboso Piave.
2. Perché il Raboso Piave è considerato un vitigno importante?
Il Raboso Piave è un vitigno storico con elevata acidità e tannicità, capace di resistere ai cambiamenti climatici e di invecchiare bene.
3. Quali sono le caratteristiche principali della filosofia aziendale di Bonotto?
Bonotto unisce tradizione e innovazione, valorizzando la memoria storica e investendo nella qualità del vino e nelle iniziative culturali.
4. Qual è il ruolo del Prosecco nella produzione della famiglia Bonotto?
Il Prosecco rappresenta una parte importante della produzione economica, mentre il Raboso è il simbolo identitario dell’azienda.
5. Cos’è Officina Malanotte e qual è il suo obiettivo?
Officina Malanotte è un progetto di residenza artistica promosso da Bonotto per favorire l’interazione tra arte, cultura e viticoltura.