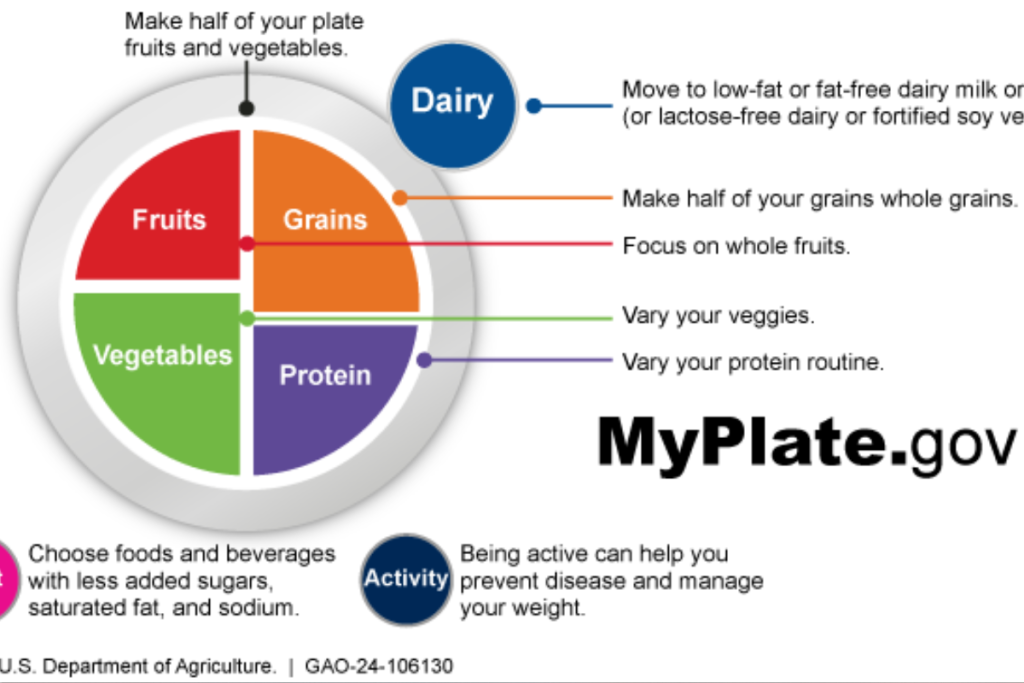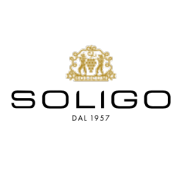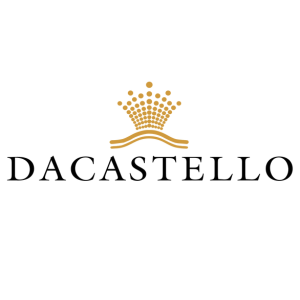Il vino dealcolato sta guadagnando attenzione tra produttori e tecnologi del settore vinicolo, ma resta poco presente per i consumatori finali. Tra innovazione, limiti sensoriali e un mercato ancora timido, emergono nuove strategie per creare prodotti validi, soprattutto tra gli spumanti. Ma l’Italia è pronta? Il futuro del dealcolato si gioca anche nella percezione.
“Con sempre più produttori impegnati nella ricerca e nello sviluppo, il vino analcolico è oggi una delle categorie più entusiasmanti del settore e il suo potenziale è illimitato.” Così si conclude l’articolo di SevenFifty Daily, a chiusura di un’analisi che racconta sperimentazioni tecniche, grandi ambizioni e un’industria in fermento – al netto dell’alcol, naturalmente.
Fuori da questi laboratori e riflettori, però, la realtà è meno dinamica. In Italia, le occasioni concrete per assaggiare un vino dealcolato rimangono rare: qualche fiera di settore, un evento mirato, qualche referenza isolata su una carta vini. Per il consumatore finale, il dealcolato è ancora più un’idea che un’opzione.
Eppure, i numeri iniziano a pesare. Anche se i vini analcolici rappresentano meno dell’1% del fatturato globale del comparto, stiamo comunque parlando di un segmento che, su un consumo mondiale stimato in 1,015 miliardi di bottiglie (dati UIV-ISMEA), vale milioni di unità. Marginale sì, ma certo non trascurabile.
In Italia nel 2024, secondo FIPE, la Federazione Italiana Pubblici Esercizi, abbiamo oltre 300.000 attività tra bar, ristoranti, imprese nel settore dell’intrattenimento e turismo. Eppure l’offerta di vini dealcolati è quasi assente, quando non del tutto inesistente. Se va bene, si trova una o due etichette di vini fermi, anche se i prodotti che ad oggi sembrano reggere meglio l’urto della dealcolizzazione sono gli spumanti.
Per capire il perché, però, bisogna tornare all’inizio: come si produce un vino dealcolato? E soprattutto, cosa cambia davvero quando si elimina l’alcol da un prodotto che sull’alcol ha costruito secoli di identità?
Per cominciare, bisogna immaginare il processo come una sorta operazione chirurgica enologica, dove si cerca di togliere qualcosa di strutturale (l’alcol) senza far crollare l’intera facciata. “Per fare un vino analcolico di qualità superiore, ci sono tre pilastri importanti,” spiega Irem Eren di BevZero a Seven Fifty Days: “Il primo è il vino di partenza, il vino base. Il secondo è il processo di dealcolizzazione, ovvero la tecnologia. Il terzo è la riformulazione o gli aggiustamenti post-dealcolizzazione. Se uno di questi tre elementi non è all’altezza, avremo difficoltà.”
Per anni, le aziende si sono concentrate sul “come” rimuovere l’alcol senza distruggere tutto il resto. Rodolphe Taittinger racconta che all’inizio perdevano “circa il 90% degli aromi. Ora, grazie a tecnologie che funzionano a temperature più basse, siamo riusciti a limitare le perdite al 60%.” Taittinger però ha capito che il problema non è solo tecnologico: “Perdi comunque il 60% dell’aroma, e anche la struttura del vino, la consistenza, molte cose.” Quindi ha cominciato a riflettere su come creare fin dall’inizio un vino adatto a essere dealcolato. E non è il solo. Anche Christian Nett, produttore tedesco, ha avuto una sorta di illuminazione dopo aver lavorato con la tecnologia Solos, decidendo che ormai la tecnica è “una cosa risolta” e che la chiave sta nel ripensare completamente la vinificazione.
Questo cambio di prospettiva porta alla questione del vino di base. L’idea che “se è buono con l’alcol, sarà buono anche senza” è stata smentita da chi ci ha provato sul serio. “Abbiamo capito che puoi prendere il miglior vino del mondo, ma se lo dealcolizzi, non otterrai un buon vino analcolico,” spiega Taittinger a Seven Fifty Days. E allora cosa fare? La sua risposta sembra essere: “creare un vino base quasi imbevibile, ma calibrato per resistere al trauma della dealcolizzazione”.
In tutto questo, le bollicine sono effettivamente avvantaggiate. Lo dice anche Duncan Shouler di Giesen Wines: “L’alcol ha una dolcezza percepita. Quando perdi quella dolcezza, l’acidità risulta più marcata, quindi bisogna trovare modi per bilanciarla.” Le bollicine mascherano alcune di queste carenze strutturali: donano corpo e distraggono con la texture. I vini fermi devono imbattersi in trucchetti da cantina come bâtonnage, lieviti inattivi e mannoproteine.
Senza dimenticare i vini rossi, che, come se non bastasse, hanno un problema in più: i tannini. “Quando togli l’alcol ai rossi, i tannini, anche se morbidi nel vino alcolico, risultano verdi, duri, sgradevoli,” spiega Nett.
Produttori ed enologi stanno cercando di risolvere un puzzle con pezzi mancanti. “È un processo di apprendimento, e ogni vendemmia è un’occasione per migliorare,” afferma Patrick Bernegger di Zeronimo, che sta lavorando a rossi dealcolati partendo da vini invecchiati 20 anni, con risultati sorprendentemente eleganti.
E quindi siamo qui. Ad aspettare la perfezione di una bevanda che non sappiamo quanto potrà mai integrarsi nel mercato. A leggere slogan sulla salubrità dei dealcolati, che possono contenere dai 3 agli 80 gr di zucchero/litro per quelli più dolci. C’è una più che sensata paura di osare e rischiare di mettere in carta vini una pagina intera di dealcolati, per il costo e per il mercato. Ma a parte qualche fortunato di settore che può provarli, il cliente finale, quello B2C, quello che muove i fatturati di un locale, non ha ancora l’idea di come venga prodotto, di che gusto abbia e se è realmente “vino”.
Fatecelo provare. Siamo disposti a pagare.
Punti chiave:
- Mercato assente in Italia: difficile reperibilità per il consumatore finale.
- Tecnologia avanzata: il dealcolato richiede processi enologici sofisticati.
- Vini base dedicati: serve ripensare la vinificazione dall’inizio.
- Spumanti avvantaggiati: texture e acidità mascherano le carenze.
- Futuro incerto: il pubblico deve ancora scoprirne gusto e valore.