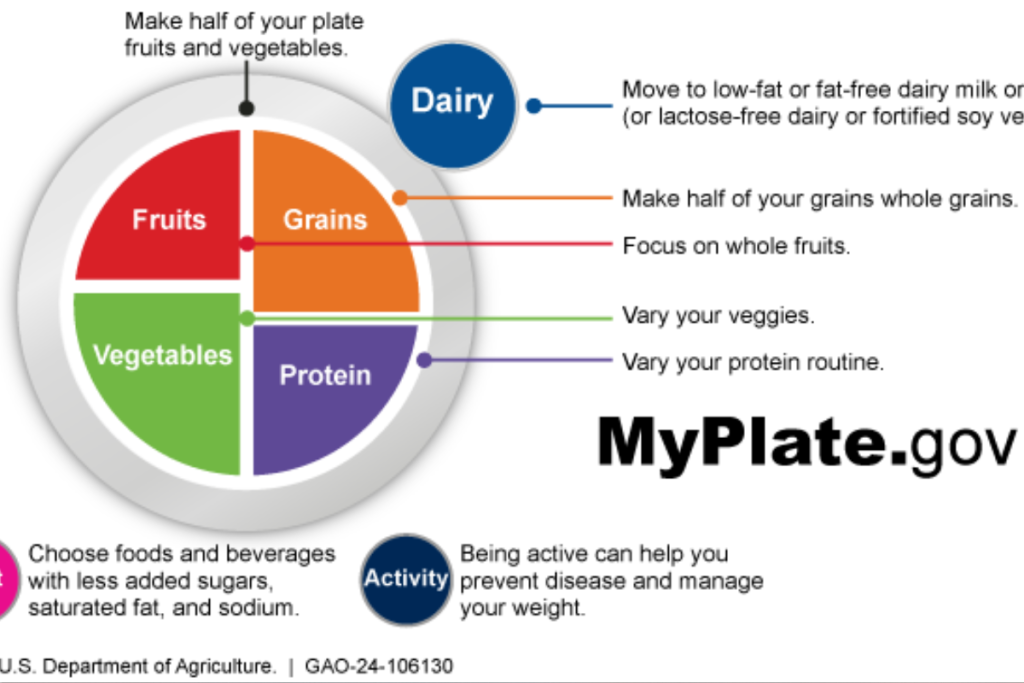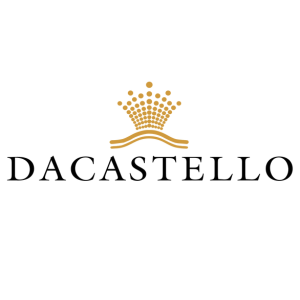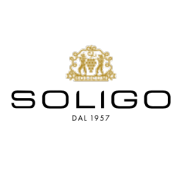Troppo comodo dare la colpa ai dazi USA: dietro le difficoltà del vino italiano si nasconde un sistema che fatica a rinnovarsi. Fabio Piccoli denuncia l’assenza di autocritica, l’immobilismo delle rappresentanze e invoca una nuova cultura d’impresa, comunicazione e promozione, in linea con i mercati e i consumatori contemporanei.
Dal momento che la nomea del “rompiballe” ormai me la sono conquistata da tempo sul campo, tanto vale continuare a non nascondersi. Anche perché a nascondersi ci riesce benissimo una gran parte del nostro settore vitivinicolo, che non c’è giorno che non trovi motivo per piangere e per lamentarsi.
E da alcuni mesi il tema dazi Usa è diventato un enorme cipolla che fa sprizzare lacrime a destra e manca.
Vi sono fortunatamente alcune eccezioni di imprenditori e manager del vino che provano sommessamente a dichiarare che i problemi del nostro vino non sono i dazi, ma una strutturazione delle nostre imprese che, a vari livelli, non risulta oggi decisamente contemporanea ed adeguata alle attuali dinamiche dei mercati.
A questo riguardo giustamente il CEO di Terra Moretti, Massimo Tuzzi, nei giorni scorsi ha dichiarato al bravo Nicola Dante Basile sul blog TerraNostra del Sole 24 Ore: “Ipotizzare che l’eventuale introduzione di dazi, qualora fossero confermati, possa alterare in modo significativo i fondamentali del commercio appare, al momento, una valutazione prematura”.
Senza dimenticare, ha sottolineato sempre Tuzzi, che le tariffe doganali rappresentano una costante negli interscambi internazionali e, piaccia o no, ci saranno anche in futuro e vanno considerate per quello che sono nelle strategie commerciali di un’impresa.
Insomma liquidare gli attuali problemi del vino italiano sul tema dell’aumento dei dazi appare l’ennesimo tentativo del nostro comparto di nascondere tutti suoi limiti sotto il tappeto.
E, scusatemi se sono ripetitivo, ma veramente faccio fatica a comprendere come non si riesca almeno a provare a confrontarsi sul da farsi preferendo sempre piangersi addosso.
Non voglio apparire ingenuo, quindi posso immaginare che anche la cortina fumogena innescata sul tema dazi dal nostro sistema vitivinicolo, in particolare da parte delle organizzazione professionali, rappresenti una sorta di appello e di stimolo alle istituzioni governative, prima fra tutte l’Unione Europea, a mettere mano al portafoglio per sostenere di più il comparto vino europeo.
E, per carità, questo lo comprendo: non faccio facili moralismi e demagogia sul fronte del supporto economico alle nostre imprese del vino.
Quello che, però, mi risulta veramente sempre più difficile comprendere e mi sta sinceramente diventando indigesto, è non leggere mai nessuna autocritica del sistema e nessuna proposta operativa di superamento di limiti strutturali e organizzativi, che sono sempre più evidenti anche all’interno della stessa rappresentanza sindacale della nostra filiera del vino.
Non c’è bisogno di stracciarsi le vesti per lesa maestà, in ogni fase di grandi cambiamenti come quella attuale tutti, e sottolineo tutti, a partire da chi fa il nostro mestiere di “cronisti del vino”, è fondamentale mettersi in discussione. Difendere a spada tratta il proprio ruolo “istituzionale”, il proprio compito professionale, a prescindere dal contributo effettivo e concreto che riusciamo a dare in un’epoca così complessa, rischia di trasformarci in quei soldati giapponesi che per decenni hanno combattuto guerre finite in terre abbandonate. In sostanza: se non vogliamo sparare a fantasmi dobbiamo finalmente disegnare obiettivi chiari che oggi sono molto diversi rispetto a quelli del passato.
A quest’ultimo proposito mi fa molto piacere che un importante Consorzio di tutela italiano, di cui al momento per correttezza professionale non posso farne il nome, stia pianificando un nuovo modello di promozione della denominazione in una chiave più accessibile, lontana dai modelli che non hanno allontanato solo i giovani dal vino ma tanti altri potenziali appassionati, a partire dalla classiche e spesso ormai insopportabili “masterclass”.
Come pure la stessa iniziativa Envisioning 2035 di cui ho già ampiamente scritto in due miei recenti editoriali (Il vino è sempre meno “abitudine” e sempre più “scelta” e Rivoluzione nel mondo del vino: spunti provocatori dal summit Envisioning 2035), ha aperto nuovi fronti di confronto che mi auguro portino a breve ad alcune proposte concrete su temi oggi fondamentali come le nuove competenze dentro le imprese del vino, nuove strategie commerciali, nuovi format e contenuti comunicativi, tanto per rimanere sulle emergenze più evidenti.
Ma affinché le nuove idee per il cambiamento del nostro sistema vitivinicolo possano trovare spazio è essenziale che almeno si riduca lo sterile piagnisteo e che si accetti il mettersi profondamente in discussione.
In ballo non c’è la sopravvivenza di qualche presidente di istituzione, di qualche giornalista di settore, di qualche imprenditore o manager di impresa, ma quella di un intero sistema che deve trovare un nuovo assetto che gli garantisca una vera competitività oggi e nel prossimo futuro.
Le idee non mancano ma facciamole uscire anche da tante voci nuove, perché il mix “idee vecchie da voci vecchie” potrebbe veramente diventare letale il vino italiano.
Punti chiave
- I dazi non bastano: non spiegano la crisi strutturale del settore vino.
- Serve autocritica costruttiva: il sistema deve rinnovarsi dall’interno.
- Nuove competenze richieste: servono approcci e modelli più attuali.
- Masterclass da rivedere: allontanano più che coinvolgere i consumatori.
- Idee nuove urgenti: da promuovere anche attraverso voci giovani.