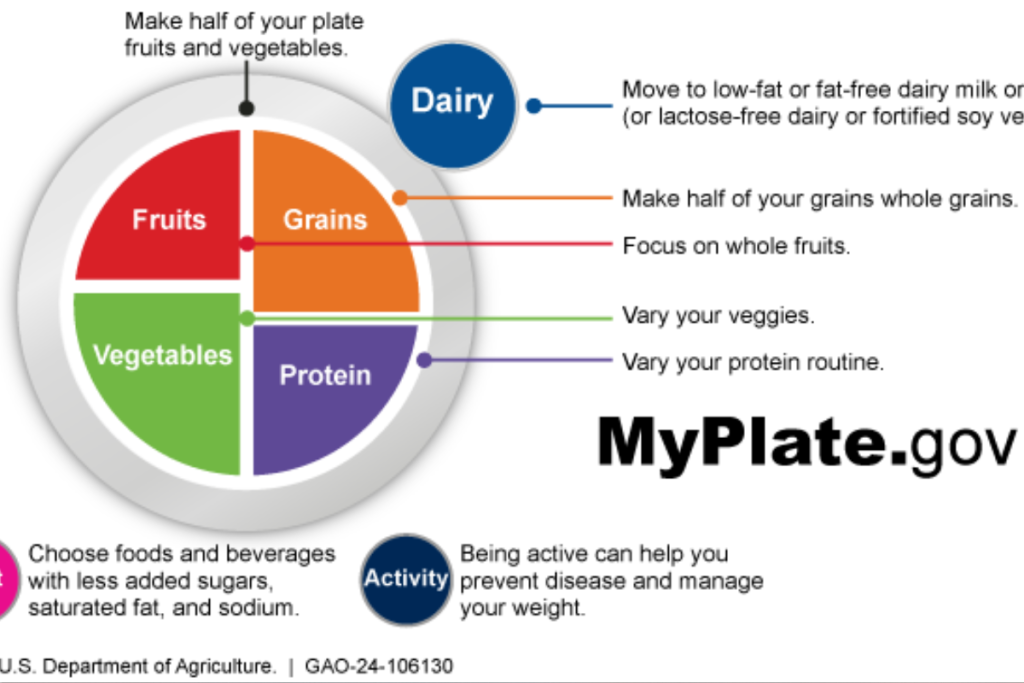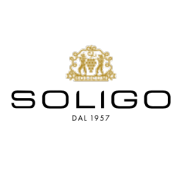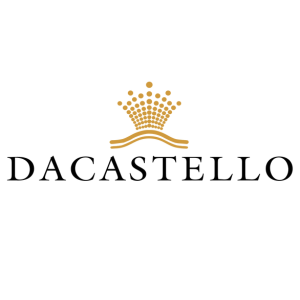In una disarmonia di slogan, narrazioni bucoliche e guerre di religione enologiche, la voce di Giovanni Bigot rappresenta un approdo sicuro: quello del dato, del processo e della conoscenza. Agronomo, consulente e ideatore dell’omonimo Indice, ha fondato nel 2018 Perleuve, una società di consulenza che si discosta dal modello tradizionale. L’obiettivo è affiancare le aziende viticole in un percorso di crescita condiviso. Il metodo è chiaro: misurare scientificamente il potenziale del vigneto per accompagnare i produttori verso decisioni più consapevoli e, in definitiva, verso una qualità autentica e costante.
Lo abbiamo intervistato per andare oltre le frasi fatte e scavare nella sostanza della viticoltura di qualità. Ne è emerso un dialogo che sostituisce l’ideologia con il processo e ci mostra come la vera eccellenza non nasca da una ricetta, ma da una profonda conoscenza.
Giovanni, partiamo da una delle frasi più iconiche del settore: “il vino si fa in vigna”. Spogliamola del romanticismo: dal punto di vista scientifico, cosa significa concretamente?
Significa che esiste una correlazione diretta, misurabile, tra le scelte agronomiche e ogni singola componente del vino che assaggiamo. Non è uno slogan, è una catena di causa-effetto. Quando parlo di “scelte”, non intendo solo le azioni, ma anche le non-azioni. Se decido di gestire la vigoria con un sovescio, se scelgo un certo sesto d’impianto, se pratico l’inerbimento o se non lo pratico, sto determinando il risultato finale. Quel livello di vigoria mi darà un certo risultato in bottiglia; se ne avessi un altro, il risultato sarebbe diverso.
Il nostro Indice, ad esempio, descrive il 95% della qualità di un vigneto attraverso nove parametri. Uno di questi, la SFE (Superficie Fogliare Esposta) per chilo di produzione, è un indicatore potentissimo. Le grandi zone viticole del mondo, quelle universalmente riconosciute, hanno quasi sempre un valore che si attesta intorno a 1,8 metri quadri di foglie per chilo d’uva. Questo non è un caso, è fisica. È la dimostrazione che “farsi in vigna” significa gestire un sistema complesso per raggiungere un equilibrio ottimale.
Questo ci porta direttamente a un altro campo minato: il “vino naturale”. Al di là delle certificazioni e delle fazioni, quando un vino può dirsi autenticamente tale secondo un approccio scientifico?
Il vino naturale è la conseguenza estrema del concetto precedente. Per me, è quel vino che nasce da un ecosistema in un equilibrio tale da richiedere un intervento umano minimo. Non è un’ideologia di partenza, è un punto di arrivo.
Le faccio un esempio concreto: il Mandrolisai, in Sardegna. Lì, per tradizione e forse per isolamento, hanno conservato un sistema viticolo straordinario. Vitigni come Bovale, Monica e Cannonau allevati ad alberello su suoli granitici. Questo sistema, per sua natura, porta a una produzione bassissima, circa 900 grammi per vite, e a un rapporto foglia/frutto perfetto, senza bisogno di diradamenti forzati. L’uva arriva a maturazione completa e sana. In quelle condizioni, hai già un’uva eccezionale, con un suo pool di lieviti complesso, che può fermentare da sola e dare un grande vino.
Ecco cos’è per me il vino naturale: il risultato di una vocazionalità del terroir sfruttata con intelligenza, dove il non-intervento è una scelta possibile perché il sistema è già in equilibrio. La naturalità è il premio per chi ha saputo creare le condizioni perfette.
Ha menzionato i lieviti, scatenando un’altra guerra di religione: indigeni contro selezionati. È una battaglia di principio o c’è una reale, misurabile differenza nel bicchiere?
La differenza c’è, ma la questione è mal posta. Non è una guerra tra bene e male, è una questione di complessità e conoscenza. Un lievito “indigeno” non è un supereroe solitario, è un pool di microrganismi: ci sono i Saccharomyces, ma anche altre famiglie come la Torulaspora, che iniziano la fermentazione e apportano sfumature uniche. È un ecosistema che lavora in successione.
Un lievito selezionato, invece, è un singolo ceppo scelto per le sue performance: vigore fermentativo, produzione di determinati aromi e, spesso, la sua capacità di dominare e “fare piazza pulita” degli altri microrganismi. Il risultato è inevitabilmente più semplice, più prevedibile.
La domanda, però, non dovrebbe essere “indigeno o selezionato?”, ma “perché lo stai usando?”. Se hai un’uva sana, un ecosistema ricco e un processo sotto controllo, aggiungere un lievito selezionato potrebbe non valorizzare al massimo il prodotto finale. Se invece lo usi perché non conosci il tuo potenziale o perché vuoi standardizzare il prodotto, è una scelta legittima, ma è una scorciatoia. La vera abilità sta nel gestire la complessità, non nell’eliminarla.
Passando a un altro argomento; immaginiamo un giovane produttore che vuole emergere in un contesto difficile, segnato dal cambiamento climatico. Qual è il consiglio più importante che gli darebbe per costruire un futuro solido?
Gli direi due cose. La prima: non fare quello che fa il tuo vicino. La seconda: per ogni scelta, chiediti il perché per cinque volte. La viticoltura italiana è malata di consuetudine. Si pianta un vitigno perché “tira” sul mercato, si adotta un sesto d’impianto perché “si è sempre fatto così”.
Chiediti: perché metto le viti a 70 cm? “Per ridurre la vigoria”. E perché vuoi ridurre la vigoria? “Per avere uva più sana”. E perché vuoi uva più sana? “Perché è la base per un vino di alta qualità”. Ecco, ora hai capito il vero obiettivo. Magari scoprirai che per ottenerlo ci sono strade migliori.
Questo approccio critico ti porta a sfidare i dogmi e a fare scelte basate sul tuo terroir specifico, non sulle mode. Ti porta a capire che forse, in quella zona del Friuli esposta al sole, la Ribolla, che ama l’asciutto, è una scelta molto più intelligente e sostenibile del Pinot Grigio. La vera differenza la farà chi smetterà di copiare e inizierà a capire a fondo il proprio contesto.
Per concludere, c’è un’innovazione tecnologica o agronomica che considera rivoluzionaria ma che vede ancora drammaticamente sottovalutata?
Sì, ed è la minima lavorazione superficiale del terreno. Non significa non fare nulla, ma utilizzare attrezzature specifiche, spesso a dischi, che lavorano solo i primissimi centimetri del suolo. Questa tecnica crea una sorta di scacchiera continua tra piccole porzioni di terra lavorata e porzioni di cotico erboso mantenuto vitale.
I benefici sono enormi e misurabili. Primo, si garantisce un’ossigenazione costante del suolo senza distruggerne la struttura. Secondo, si mantiene la biodiversità del cotico. Terzo, e questo è il dato più incredibile, si aumenta la microporosità del terreno a tal punto che abbiamo misurato un incremento del 30% della capacità di ritenzione idrica in soli tre anni. In un’epoca di siccità e stress idrico, questo è un vantaggio competitivo enorme.
Significa abbandonare aratri, frese, ripuntatori e affidarsi a un solo attrezzo, più veloce, economico e leggero. Sembra troppo semplice per essere vero, e questo genera diffidenza. Ma è qui che si gioca una parte importante della viticoltura del futuro: nell’intelligenza di adottare soluzioni più efficienti e sostenibili, anche se vanno contro ciò che “si è sempre fatto”.
La vera sfida che emerge non è scegliere tra naturale e convenzionale, tra legno e acciaio, tra indigeni e selezionati. La vera sfida è avere il coraggio di conoscere. Conoscere il proprio suolo non solo per tradizione, ma attraverso dati misurabili. Conoscere i propri vitigni non solo per nome, ma per la loro reale interazione con il microclima. Conoscere il proprio processo non solo per abitudine, ma per essere in grado di guidarlo anziché subirlo.
In questo, l’approccio scientifico di Bigot non è un’alternativa all’artigianalità, ma il suo più potente alleato. È lo strumento che permette di trasformare l’intuizione in certezza, l’esperienza in un modello replicabile e migliorabile.
Il futuro del vino italiano si giocherà sulla capacità di ogni singolo produttore di diventare il primo e più profondo conoscitore del proprio vigneto, armato di dati, curiosità e, soprattutto, di quei cinque, fondamentali, “perché”.
Punti chiave
- Qualità in vigna: Non uno slogan, ma una catena misurabile di causa-effetto tra scelte agronomiche e risultato finale.
- Vino naturale: Non un’ideologia, ma il punto d’arrivo di un ecosistema in perfetto equilibrio che richiede interventi minimi.
- Lieviti indigeni vs selezionati: Una questione di complessità e conoscenza, non una battaglia tra bene e male per standardizzare il prodotto.
- Consiglio ai giovani: Non copiare il vicino e chiediti il “perché” di ogni scelta per sfidare le consuetududini.
- Innovazione sottovalutata: La minima lavorazione del suolo aumenta la ritenzione idrica del 30%, un vantaggio enorme contro la siccità.