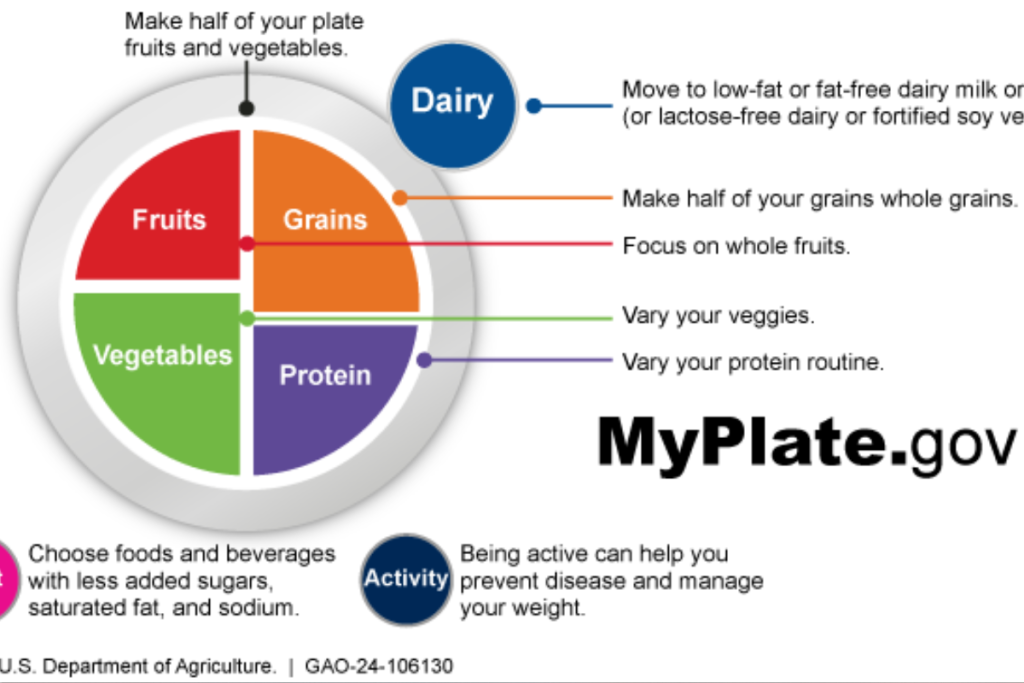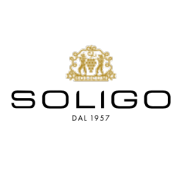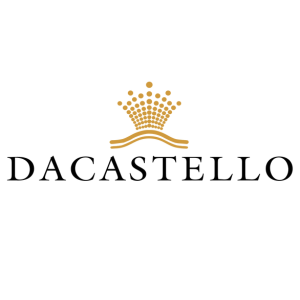Hervé Grosjean sogna una Valle d’Aosta vitivinicola che rifiuta l’autoreferenzialità e guarda oltre i confini. Tra memoria storica, comunicazione autentica, apertura ai mercati internazionali e uso consapevole della tecnologia, emerge una visione lucida: innovare senza tradire la tradizione e assumersi la responsabilità di far crescere un territorio unico e fragile.
Hervé Grosjean è una di quelle figure che aiutano a capire perché la Valle d’Aosta non sia solo un territorio “estremo” e confinato, ma un progetto in divenire. Produttore tra i più noti della regione, Grosjean ha costruito la propria visione partendo da un profondo rispetto per la storia familiare e per le radici viticole valdostane, senza però mai smettere di guardare oltre le montagne.
La sua è una viticoltura che non si accontenta dell’autoreferenzialità: comunicare in modo concreto, raccontare ciò che è stato e ciò che accade davvero in cantina, investire in tecnologia e aprirsi ai mercati internazionali sono scelte precise, non slogan. In questa intervista emerge con chiarezza una visione lucida e non compiacente: l’innovazione non come rottura della tradizione, ma come sua naturale evoluzione; l’export come necessità per crescere; la comunicazione e l’enoturismo come responsabilità verso il territorio. Un racconto che va oltre la singola azienda e diventa riflessione aperta sul futuro della Valle d’Aosta del vino.
Come è iniziata la Sua avventura nel vino?
Io sono cresciuto in famiglia, nell’azienda, guardando la storia dei miei genitori e di mio nonno. Ho sempre fatto riferimento al punto zero degli anni Cinquanta e Sessanta, quando mio nonno ha cominciato. Poi ho avuto la fortuna di conoscere un grande amico, Rudy Sandi, appassionatissimo di viticoltura e di storia della viticoltura, che mi ha aiutato a capire cosa si faceva in Valle d’Aosta prima di noi, prima di mio nonno, prima delle guerre mondiali. Così ho iniziato a scoprire e a leggere quello che si faceva dal Medioevo, nel periodo in cui la viticoltura era al suo massimo splendore, quando c’erano 3.500 ettari vitati sul territorio valdostano, mentre oggi ne abbiamo poco più di 450. In questi documenti storici si legge che una buona bottiglia di Passito di Chambave valeva quasi due bottiglie di un buon rosso di Borgogna. Questa cosa mi rende orgoglioso e mi spinge ancora di più a comunicare. Per questo ho voluto fortemente installare pannelli esplicativi sul territorio, con un onere anche economico per l’azienda, perché la gente ha voglia di conoscere realmente cosa c’era prima, oltre a conoscere noi in prima persona. A me piace raccontare partendo da lontano, perché noi siamo ancora solo all’inizio della nostra storia: stiamo iniziando adesso a scriverla.
In che tipo di comunicazione crede?
Io credo in un sistema di comunicazione reale, mi piace raccontare la pura e semplice realtà dei fatti, senza creare delle storie costruite su qualcosa che non regge. Quello che a me piace trasmettere è la pura e semplice realtà dei fatti che avvengono all’interno della nostra cantina. Mi piace raccontare la storia passata, il territorio, tutte queste cose perché legano molto di più ancora la nostra Valle d’Aosta e i nostri comunicati, e quindi mi piace molto unire la nostra storia importantissima a quello che stiamo facendo adesso.Oggi molti pensano di avere una viticoltura in Valle d’Aosta importante, quando poi, se ci vogliamo guardare indietro, avevamo una viticoltura dieci volte più importante di quella che abbiamo adesso in passato. Questo ci fa solo capire che abbiamo bisogno di comunicare ancora meglio il territorio e di crescere ancora di più.
Cosa manca in Valle d’Aosta oggi per eccellere?
Secondo me oggi manca un po’ la voglia di uscire da parte dei produttori. Noi siamo cresciuti molto da quando ho preso in mano l’azienda, che era sana sia a livello economico sia strutturale, e questo mi ha permesso di investire. Siamo passati da una produzione media di 80 mila bottiglie a un potenziale di circa 220 mila bottiglie. Siamo arrivati a questo livello perché ho guardato fuori, fuori dalle nostre bellissime montagne. Ho iniziato a esportare più di vent’anni fa negli Stati Uniti e oggi tocchiamo circa 50 Paesi nel mondo.
Perché la Valle d’Aosta non è così conosciuta l’estero…
Quando vai all’estero e dici Valle d’Aosta, spesso ti chiedono dove sia. Allora inizi a spiegare, parli del Monte Bianco, del Cervino, e capisci che la nostra comunicazione deve partire da zero. Bisogna ancora far capire al turista che viene a sciare o a camminare in Valle d’Aosta che qui si fa anche vino. Le cose stanno cambiando, ma c’è ancora tantissimo lavoro da fare. A volte neanche i nostri concittadini ci conoscono, per questo il lavoro di comunicazione sul territorio è ancora enorme.
La nostra fortuna è che la Valle d’Aosta è piccola e produce pochissimo. Questo ci protegge. Se producessimo il doppio, avremmo un esubero enorme. Il territorio è difficilissimo, la resa per ettaro è bassissima, e questo ci garantisce un commercio più facilitato. Io esportando circa il 50% della produzione vedo cosa succede attorno: Bordeaux è in difficoltà, in Francia e in Svizzera la situazione è complicata, molte cooperative non riescono nemmeno a ritirare tutte le uve. Noi probabilmente sentiremo questa crisi più avanti, come spesso succede.
Quali sono i vostri punti di forza?
La bassa produzione e l’unicità del territorio, che nessuno può replicare.
Un aspetto che la preoccupa?
Vedo tanta voglia di crescere a tutti i costi, e questo può diventare un’arma a doppio taglio. Qui non ci sono aziende o vigneti in vendita, il mercato è piccolissimo e molto legato al territorio. Un altro aspetto che mi spaventa è la quantità enorme di vino in Italia. Forse abbiamo superato un limite, piantato vigneti dove non dovevano esserci. Continuare a produrre sempre quel 20-30% di vino in più abbassa il valore di tutto il resto. È una mia riflessione personale, ma nel mio piccolo lo vedo così: produrre vino mediocre non so se abbia ancora senso.
Come fare fronte ad un passaggio generazionale in una famiglia numerosa come la vostra?
Noi siamo quattro cugini a mandare avanti l’azienda, con lo zio ancora operativo. La chiave è stata dare ruoli e responsabilità ben definite. Ognuno ha il proprio confine e questo fa funzionare il sistema. Siamo una vera azienda familiare, un team giovane e affiatato, dove si lavora tutti insieme.
Cos’è l’innovazione per voi?
Per noi l’innovazione è fondamentale, soprattutto nella comunicazione e nella tecnologia. Viviamo di tradizione e territorio, ma il grande errore del valdostano è chiudersi. Senza turismo e senza apertura non si va avanti. Abbiamo investito in tecnologia di cantina per migliorare la qualità e rendere il lavoro meno faticoso. Tradizione e tecnologia devono convivere.
Guardando al futuro, cosa vede?
Guardando al futuro, vedo un’azienda che ha raggiunto una dimensione gestibile come vera azienda familiare. Ora la sfida è mantenere quello che abbiamo costruito, che spesso è più difficile che crescere. Il prodotto valdostano ha un grande futuro: siamo in una delle zone più fresche d’Italia, abbiamo vitigni autoctoni e tardivi che possono solo migliorare con il cambiamento climatico. Il consumatore oggi cerca vini sinceri, freschi, beverini, poco alcolici. È un trend che spero continui, e su cui stiamo lavorando da anni.
Punti chiave:
- La viticoltura valdostana come progetto in divenire, non come enclave chiusa.
- Comunicazione reale e storicamente fondata come responsabilità verso il territorio.
- Export e apertura ai mercati internazionali come necessità strutturale.
- Produzioni limitate e unicità territoriale come fattori di forza.
- Innovazione tecnologica come evoluzione naturale della tradizione.