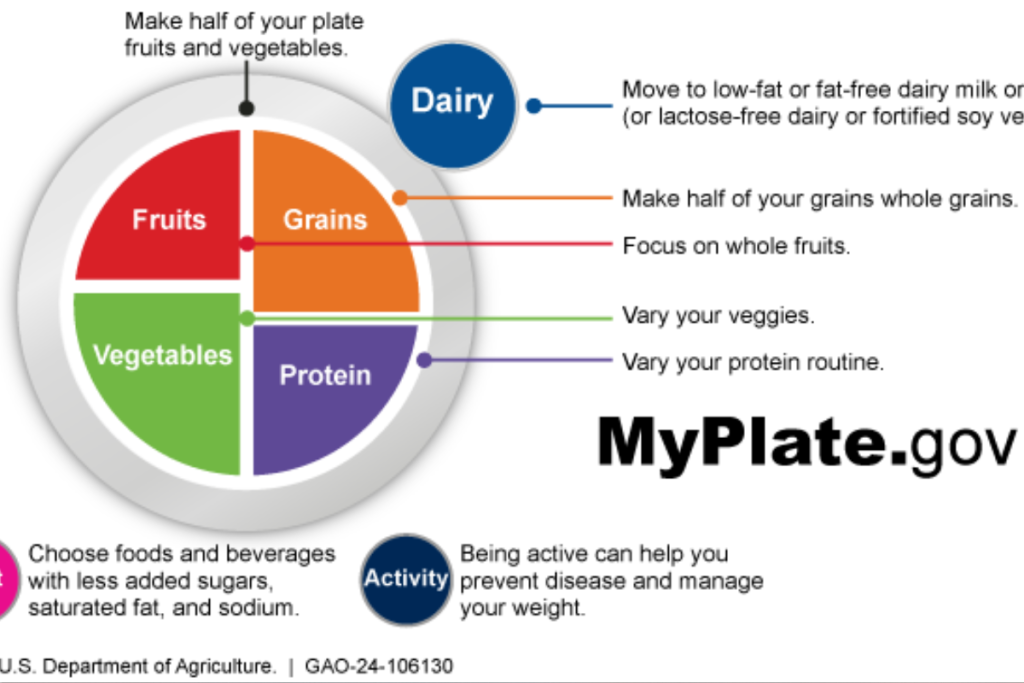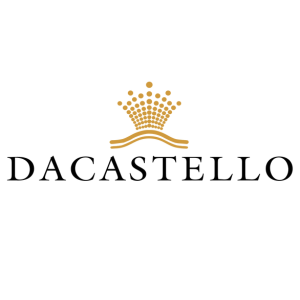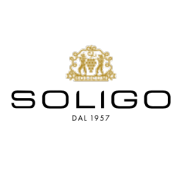Il vino non è in crisi: lo è il contesto economico che lo circonda. Jim Silver sostiene che crescita continua, velocità e standardizzazione snaturano un prodotto agricolo che vive di tempo e complessità. La scomparsa degli intermediari culturali e l’omologazione hanno reso il vino accessibile ma impersonale, generando consumatori annoiati più che disinteressati.
Mai come in questo periodo mi imbatto in articoli e analisi che affrontano il tema della cosiddetta “crisi del vino”. Sono in molti – analisti, economisti, giornalisti, blogger – che cercano di dare una lettura dello stato attuale dei mercati vitivinicoli e, in particolare, delle ragioni che stanno portando a un evidente calo dei consumi. Tra queste voci, mi ha colpito in modo particolare la visione espressa da Jim Silver nell’articolo “The Problem with the Wine Business Is Business – Constant Growth is Incompatible with Growing Wine”, pubblicato il 27 dicembre 2025 sulla newsletter Substack The View from the Cheap Seats.
Un’analisi che, per certi aspetti, ribalta molte delle interpretazioni oggi dominanti sulla crisi del vino, comprese alcune delle mie. E questa, per me, è una buona notizia. Non c’è infatti nulla di più pericoloso che innamorarsi delle proprie convinzioni e considerarle sempre valide, indipendentemente dal contesto. È proprio questo atteggiamento che spesso ci porta a restare immobili su posizioni rassicuranti, ma incapaci di interpretare correttamente una fase complessa e in rapida trasformazione come quella che stiamo vivendo.
Silver non nega la crisi, né minimizza i dati sul calo dei consumi. Ma sposta radicalmente il punto di osservazione. La sua tesi è che il problema del vino non sia il vino in sé, né una perdita di interesse culturale o simbolico da parte dei consumatori. Il problema, semmai, è il contesto nel quale il vino è stato progressivamente inserito: un sistema economico e commerciale che richiede crescita continua, velocità, standardizzazione e prevedibilità. Tutte caratteristiche che mal si conciliano con la natura profonda del vino.
Il vino non è un prodotto industriale replicabile all’infinito. È un prodotto agricolo, vivo, soggetto a limiti naturali, a cicli lunghi, a variazioni imprevedibili. Eppure, negli ultimi decenni, lo abbiamo costretto a comportarsi come se fosse software, moda o beni di largo consumo. Abbiamo chiesto al vino di crescere sempre, di essere coerente, rassicurante, facilmente leggibile, immediatamente disponibile. In altre parole: gli abbiamo chiesto di adattarsi a logiche che non gli appartengono.
Secondo Silver, questa forzatura non ha prodotto un fallimento clamoroso, ma qualcosa di più sottile e insidioso: un progressivo assottigliamento del vino. Meno differenze reali, meno rischio, meno identità. Un’abbondanza apparente di etichette che, però, finiscono per assomigliarsi sempre di più. Il vino è diventato facile da acquistare, ma sempre più difficile da sentire, da ricordare, da raccontare.
Uno dei passaggi più interessanti della sua analisi riguarda la scomparsa degli intermediari umani. Enotecari, ristoratori, importatori, comunicatori competenti non erano semplici anelli inefficienti della filiera: erano traduttori culturali. Figure capaci di creare contesto, relazione, memoria. La loro progressiva sostituzione con piattaforme, algoritmi, punteggi e metriche ha reso il vino più accessibile, ma anche più impersonale. Abbiamo confuso l’abbondanza con la scelta, l’informazione con la comprensione, la velocità con il valore.
In questo quadro, la cosiddetta “crisi del vino” appare sotto una luce diversa. Forse non siamo di fronte a consumatori confusi o disinteressati, ma a consumatori annoiati. Saturi di messaggi, di branding, di promesse indistinte. Persone che non cercano necessariamente meno vino, ma meno rumore e più senso. Meno schede tecniche e più conversazioni. Meno “contenuti” e più esperienze autentiche.
Silver non invoca un ritorno nostalgico al passato né una fuga dalla modernità. Riconosce il ruolo fondamentale della tecnologia, dell’e-commerce, della logistica. Ma invita il settore a riconsiderare le proprie aspettative di crescita e, soprattutto, il proprio linguaggio. Perché quando tutto viene misurato in termini di performance, velocità e conversione, ciò che non è immediatamente quantificabile – emozione, memoria, relazione – rischia di scomparire. Ed è proprio lì che il vino trova il suo senso più profondo.
Forse, allora, la vera sfida non è “salvare il vino”, ma imparare di nuovo a tradurlo. Accettare che non tutto debba crescere all’infinito, che non tutto debba essere semplificato, che non tutto debba essere ottimizzato. In un’epoca stanca di sistemi che spiegano tutto e non fanno sentire nulla, la lentezza e la resistenza del vino alla standardizzazione possono tornare a essere una virtù, non un limite.
Punti chiave
- Il problema non è il vino ma il sistema economico che richiede crescita continua, velocità e standardizzazione incompatibili con la sua natura agricola.
- La standardizzazione ha assottigliato l’identità del vino, creando abbondanza di etichette sempre più simili tra loro e meno memorabili.
- Gli intermediari culturali scomparsi (enotecari, ristoratori) erano traduttori essenziali, sostituiti da algoritmi che rendono il vino impersonale.
- I consumatori sono annoiati, non confusi: cercano meno rumore e più senso, meno contenuti e più esperienze autentiche.
- La lentezza del vino può tornare virtù in un’epoca stanca di ottimizzazione, accettando che non tutto debba crescere infinitamente.