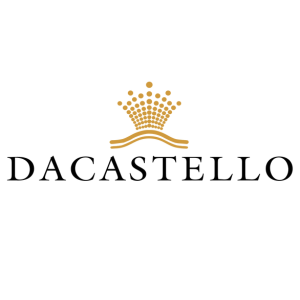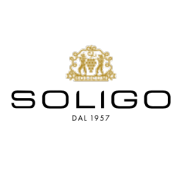Francesco Ganz, CEO di Ethica Wines, analizza le trasformazioni del mercato americano del vino italiano. Dalla crescita delle cucine non italiane alla riduzione dei consumi per motivi salutistici, fino al ruolo strategico della distribuzione: un quadro lucido sulle sfide che produttori e istituzioni devono affrontare per competere globalmente.
Abbiamo intervistato Francesco Ganz, CEO di Ethica Wines, a margine della sua presentazione tenuta in Piemonte, in occasione dell’evento annuale di Vignaioli Piemontesi, durante il quale è stata proposta una relazione approfondita sul mercato americano del vino.
Ethica Wines è oggi uno dei principali punti di riferimento per l’importazione di vino italiano negli Stati Uniti e in Canada. Con circa 140 milioni di dollari di fatturato e oltre 20 milioni di bottiglie importate ogni anno, l’azienda opera su tutto lo spettro del mercato, dalla ristorazione al retail specializzato fino alle grandi catene nazionali.
Nel suo intervento, Ganz ha offerto una lettura lucida e talvolta provocatoria delle dinamiche che stanno trasformando il consumo di vino negli USA, invitando produttori e istituzioni a superare autoreferenzialità e approcci difensivi per affrontare un mercato in profondo cambiamento
Ethica Wines è oggi una realtà di riferimento nel mercato nordamericano. Che tipo di azienda siete diventati?
Ethica Wines è nata circa dieci anni fa e oggi opera come importatore specializzato esclusivamente in vino italiano. Lavoriamo negli Stati Uniti e in Canada e in Asia Pacific, coprendo sia il canale on trade sia il retail, dal dettaglio specializzato alle grandi catene nazionali. I nostri clienti diretti sono i distributori, secondo il modello americano del “three-tier system”, ma affianchiamo questa struttura con una nostra forza vendita controllata, per garantire attenzione e visibilità ai prodotti.
Quanto conta conoscere davvero la struttura del mercato americano?
Conta moltissimo. Negli Stati Uniti non basta avere un buon vino: bisogna conoscere il sistema distributivo, le dinamiche dei singoli Stati, il ruolo dei distributori e dei retailer. Fermarsi idealmente “alla porta della cantina” non è più sufficiente: bisogna arrivare fino al punto di vendita e laddove possibile al consumatore finale.
Uno dei temi centrali del suo intervento riguarda il cambiamento della ristorazione. Cosa sta accadendo?
Spesso in Italia siamo portati a pensare che tutto il mondo mangi italiano. In realtà non è così, soprattutto negli Stati Uniti. In città come Miami, dove vivo, la ristorazione è cresciuta moltissimo, ma non è cresciuta quella italiana. Si sono affermate cucine come la giapponese, la coreana, la peruviana e più in generale quelle asiatiche e sudamericane.
Qual è l’impatto di questo fenomeno sul vino italiano?
L’impatto è diretto: il vino italiano è fortemente sottorappresentato nelle carte vini dei ristoranti non italiani. Se apriamo la carta di un ristorante asiatico o sudamericano negli Stati Uniti, l’Italia occupa pochissimo spazio rispetto alla qualità e alla varietà della sua produzione. È una realtà che dobbiamo affrontare.
Qual è quindi la sfida principale per i produttori italiani?
Imparare a vendere il vino italiano al di fuori della ristorazione italiana. Continuare a dipendere quasi esclusivamente dai ristoranti italiani è un limite strutturale. La promozione del vino italiano deve diventare più trasversale e meno legata a un solo tipo di cucina.
Anche il consumatore americano sta cambiando. In che modo?
Sta cambiando profondamente. Negli Stati Uniti la riduzione dei consumi di alcol è legata soprattutto a motivazioni salutistiche, spesso amplificate dai social media. Il vino è particolarmente esposto perché è una categoria meno protetta rispetto ad altre, come gli spirits. Bere vino non è più un gesto automatico: deve diventare un’esperienza.
Cosa significa oggi “esperienza di consumo” applicata al vino?
Significa che il vino non può più essere bevuto solo perché è vino. Devono emergere identità forti: dell’azienda, del prodotto, del territorio. Saranno queste identità a muovere i consumi. È anche una delle ragioni per cui gli spumanti mostrano maggiore resilienza: comunicano più facilmente valori emotivi ed esperienziali.
Nel suo intervento ha sottolineato il ruolo strategico della distribuzione. Perché è così centrale?
Perché la qualità, da sola, non basta più. Le sfide future si vinceranno con la conoscenza dei mercati e con la capacità di penetrarli attraverso strutture distributive efficaci. Serve maggiore attenzione, anche da parte del settore pubblico, alle filiere distributive e non solo alla produzione.
In questo contesto entra in gioco anche il tema del lobbying. In che senso?
Lobbying significa formazione, educazione, presenza nei luoghi che contano. La Francia, da questo punto di vista, è molto avanti: investe da anni sulla formazione di sommelier, buyer e operatori. Nei principali testi di formazione internazionale, come il WSET, il vino italiano è ancora marginale rispetto a Francia e California. Questo è un limite che dobbiamo colmare.
Secondo lei qual è il primo brand da promuovere oggi?
Il vero brand da promuovere è il vino italiano nel suo complesso. Il consumatore americano sceglie prima di tutto tra Italia, Francia e California. Solo in un secondo momento arriva alle denominazioni. Rafforzare il brand “vino italiano” porterebbe benefici trasversali a tutte le regioni.
Che ruolo dovrebbero avere le istituzioni?
Un ruolo molto più incisivo. Servirebbe una grande campagna istituzionale di alto profilo per la promozione del vino italiano sui mercati esteri, in particolare negli Stati Uniti. Le risorse ci sono: bisogna decidere di usarle in modo strategico e coordinato.
Dal punto di vista degli imprenditori, invece, quale approccio consiglia?
Consapevolezza. I mercati esteri, soprattutto quelli lontani e complessi, sono costosi e impegnativi. Non sempre ha senso esserci. Bisogna avere chiari obiettivi, limiti, forza del brand e dimensione aziendale. In alcuni casi è più intelligente consolidarsi sul mercato locale piuttosto che affrontare mercati come quello americano senza le giuste condizioni.
Ha concluso il suo intervento con una provocazione sul vino dealcolato. Ce la spiega?
Non è un invito a produrre vini dealcolati, ma un invito all’apertura mentale. Nel mondo della birra e degli spirits il low e no alcohol è stato gestito come opportunità strategica. Non dobbiamo porre ostacoli ideologici: per alcune categorie potrebbe rappresentare un’opportunità e non una minaccia.
In sintesi, qual è il messaggio che vuole lasciare al settore?
Non essere autoreferenziali, ascoltare chi vive nei mercati, investire su identità, distribuzione e promozione. Il vino italiano ha enormi opportunità, ma solo se accetta di competere davvero a livello globale.
Punti chiave
- La ristorazione negli USA sta cambiando: crescono cucine asiatiche e sudamericane, non quella italiana, con impatto negativo sul vino italiano.
- Il vino italiano è sottorappresentato nelle carte vini dei ristoranti non italiani negli Stati Uniti rispetto alla sua qualità.
- I consumi di alcol calano per motivazioni salutistiche: il vino deve diventare esperienza con identità forti di territorio e prodotto.
- Serve lobbying efficace: la Francia investe da anni su formazione e presenza nei testi internazionali come il WSET.
- Il brand “vino italiano” deve essere promosso nel complesso con campagne istituzionali coordinate prima delle singole denominazioni.