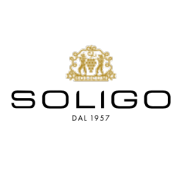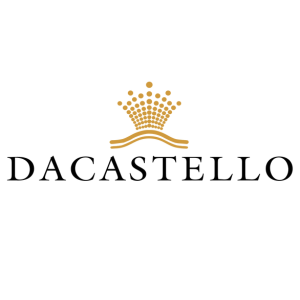Si denuncia la svalutazione culturale dell’enoturismo in Italia, considerato dai produttori un’attività di ripiego rispetto al prestigio dell’export. Questa mentalità frena un canale di business strategico e redditizio, basato sulla relazione diretta con il consumatore, e mantiene il settore un passo indietro rispetto ai competitor internazionali che hanno già investito con successo sull’accoglienza.
Diciamocelo chiaramente: l’Italia del vino non ha ancora capito il potenziale reale dell’enoturismo. Lo sfiora, lo nomina, lo inserisce nei piani strategici di qualche consorzio o nei discorsi da convegno. Ma la verità è che siamo ancora tra gli ultimi della classe nel valorizzare seriamente questo canale. E lo siamo non perché non ne riconosciamo i numeri, ma perché culturalmente non lo consideriamo abbastanza “nobile”.
Per decenni, abbiamo puntato tutto sull’export. E in parte, è andata bene così. Ma oggi quel modello, da solo, non basta più. La vendita diretta, l’accoglienza, la relazione con chi arriva in cantina, non sono un piano B. Sono – e dovrebbero essere – un modello di business primario, strategico, sostenibile. Lo hanno capito prima di noi americani, australiani, sudafricani, cileni. E mentre loro strutturavano esperienze e fidelizzavano clienti, noi continuavamo a rincorrere buyer e listini all’estero.
Quello che fa davvero riflettere, però, è un concetto che ci siamo sentiti dire da più di un produttore durante il nostro Summer Tour:
“Restare in azienda a vendere il vino ai turisti mi fa sentire come se avessi fallito.”
Fallito, sì. Perché nella mentalità di molti, l’estero è la vera consacrazione del vino italiano, mentre la cantina aperta al pubblico è ancora percepita come un parcheggio temporaneo per chi “non è riuscito” a fare carriera internazionale. Una mentalità sbagliata, tossica, che rischia di farci perdere l’unica vera leva di competitività che oggi possiamo ancora giocare: la relazione diretta con il consumatore.
Eppure, sarebbe così semplice. Vendere direttamente, conoscere i clienti, raccontare il vino senza filtri, creare community. Ogni bottiglia venduta in cantina ha un margine più alto, un impatto emozionale più forte, una ricaduta positiva sul territorio. Cosa c’è di fallimentare in tutto questo?
Il problema è che manca la consapevolezza culturale, prima ancora che imprenditoriale. La formazione interna spesso non contempla nemmeno le basi dell’accoglienza. Non si investe sulle persone, sul tempo da dedicare all’esperienza. Non si lavora sulla narrazione. E soprattutto, non si fa pace con l’idea che l’enoturismo possa essere un punto d’arrivo, non di ripiego.
È chiaro, nessuno sogna di passare la vita tra una visita guidata e una degustazione. Ma perché l’alternativa dovrebbe essere per forza un aereo per New York o una fiera in Germania? Chi l’ha detto che il successo passa solo attraverso i mercati esteri? Perché valorizzare il proprio terroir, aprire le porte della propria azienda, costruire un’identità forte sul territorio non dovrebbe essere considerato “cool”?
La verità, anche se scomoda, è che finché il nostro settore continuerà a vedere l’enoturismo come una scelta di serie B, non costruiremo mai un sistema solido, replicabile, sostenibile. Finché i figli dei produttori sogneranno solo di “fuggire” all’estero invece di innovare in azienda, l’Italia del vino continuerà a giocare in difesa, sempre un passo indietro rispetto a chi ha capito da tempo che vendere è anche – e soprattutto – raccontare.
Abbiamo bisogno di un reset culturale. Di aziende che mettano l’accoglienza al centro. Di produttori che siano orgogliosi di vendere il vino a chi varca il cancello della loro cantina. Di figli e figlie che vedano nella relazione con il pubblico un’opportunità, non un sacrificio. Solo così l’enoturismo smetterà di essere la ruota di scorta del settore e diventerà ciò che potrebbe già essere: una colonna portante della competitività del vino italiano.
E, magari, la prossima volta che qualcuno ci chiederà perché siamo ancora così indietro, avremo il coraggio di rispondere: “Perché abbiamo pensato troppo all’export, e troppo poco a chi è venuto a bussare alla nostra porta.”
Punti chiave
- Enoturismo visto come un fallimento culturale, secondario rispetto alla consacrazione ottenuta con l’export.
- Manca una mentalità imprenditoriale che veda l’accoglienza come un modello di business primario e strategico.
- Relazione col consumatore è la vera leva competitiva, oggi persa inseguendo unicamente i mercati esteri.
- Serve un reset culturale per mettere l’ospitalità e la narrazione al centro del valore aziendale.