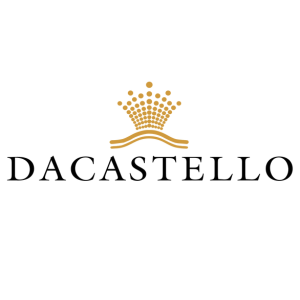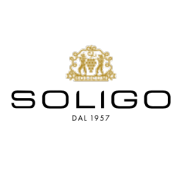Gabriele Gorelli, primo Master of Wine italiano, denuncia l’atteggiamento elitario del settore vinicolo verso i consumatori. Mentre altri comparti valorizzano l’emozione, il vino pretende competenza tecnica. Serve un cambio di paradigma: rendere accessibile senza impoverire, costruire ponti invece di barriere. Una riflessione che segna un prima e un dopo nella comunicazione del vino.
C’è un passaggio dell’intervista rilasciata da Gabriele Gorelli a Wine Meridian (Gabriele Gorelli: “Vince chi insiste, chi ripiega autoalimenta la propria decrescita”), primo Master of Wine italiano, che negli ultimi giorni ha fatto molto discutere. Una riflessione semplice nella forma ma dirompente nella sostanza:
“Il mondo del vino si è purtroppo dimostrato l’unico settore in cui esiste una sorta di risentimento verso il consumatore se non dimostra competenza.”
Un’osservazione che pesa non per il tono provocatorio – tutt’altro – ma per la sua lucidità. E perché a esprimerla è una delle voci più autorevoli della comunicazione del vino nel nostro Paese.
Gorelli prosegue sottolineando un concetto che raramente viene articolato con tale nettezza: mentre altri settori, dal lusso alla moda, dall’automotive al design, hanno imparato a valorizzare l’emozione e l’immediatezza del coinvolgimento del consumatore, il mondo del vino continua spesso a pretendere di “educarlo”, come se l’acquisto o la scelta di un bicchiere dovessero necessariamente passare per un esame di competenza tecnica.
In questo atteggiamento – che Gorelli definisce con il termine anglosassone weaponizing, ovvero “usare la conoscenza come un’arma” – si cela una contraddizione culturale che il settore non può più permettersi. Consegnare a un tavolo di sei persone una carta dei vini intimidatoria, complessa, pensata più per celebrare chi la scrive che per guidare chi la legge, significa mettere il consumatore in difficoltà. E non c’è da stupirsi se poi sceglie un cocktail: immediato, riconoscibile, privo di giudizio incorporato.
La fine di un modello (che non ha più ragione di esistere)
Le parole di Gorelli non sono solo una critica al passato: rappresentano un punto di partenza necessario. Certificano – o dovrebbero certificare – la fine di un modello comunicativo che ha a lungo coltivato un elitismo sterile, convinto che la complessità fosse di per sé valore, che la distanza fosse autorevolezza, che il consumatore dovesse “meritarsi” il vino.
Quel modello non funziona più.
Non perché il vino debba diventare semplice, banale, fast-food liquido: nessuno auspica questo. Ma perché democratizzare non significa semplificare, significa rendere accessibile senza impoverire. Significa costruire ponti, non erigere barriere.
E, paradossalmente, proprio chi possiede più conoscenza – come Gorelli – è nella posizione ideale per guidare questo cambiamento.
Il problema: quanti la pensano davvero così?
La domanda che segue è inevitabile: quanti, nel mondo del vino italiano, condividono davvero questa visione?
Perché se è vero che esiste una sensibilità nuova, più aperta e più “customer-centric”, è altrettanto vero che una parte consistente del settore sembra ancora aggrappata a ritualità, linguaggi ed eventi pensati per confermare un’appartenenza, non per allargare un pubblico.
Le comunicazioni che riceviamo quotidianamente lo testimoniano: troppe aziende parlano ancora al vino più che del vino, ai tecnici più che ai consumatori, all’élite più che al mercato reale. Troppi eventi continuano a ricalcare format autoreferenziali, difficili, “per addetti ai lavori”, quasi volessero ribadire che il vino è un club a cui si accede per conoscenza (nel doppio senso del termine).
Ma in un mondo in cui i linguaggi cambiano rapidamente, in cui la cultura dell’esperienza è centrale e il pubblico cerca autenticità e prossimità, questo approccio rischia di trasformarsi in un boomerang: riduce la platea, limita il dialogo, indebolisce la vitalità del settore.
Un nuovo patto tra vino e consumatore
Se il vino vuole tornare a essere un linguaggio universale – com’è nella sua natura – deve fare un passo indietro per farne tre in avanti. Deve rinunciare al ruolo di “educatore” e assumere quello di compagno di viaggio: capace di raccontare storie, territori, emozioni, valori.
La competenza rimane fondamentale, certo. Ma deve essere una risorsa, non un discrimine; un invito, non una barriera; una chiave, non un’arma.
Il punto sollevato da Gorelli non è una provocazione. È una chiamata alla responsabilità. E soprattutto è un’opportunità: quella di ridisegnare il futuro della comunicazione del vino secondo una logica più inclusiva, contemporanea, umana.
Il settore è pronto? Forse non ancora. Ma il dibattito è finalmente aperto. E ignorarlo significherebbe restare indietro proprio nel momento in cui il vino avrebbe più bisogno di essere compreso, scelto e amato da un pubblico ampio, curioso e non più disposto a sentirsi “inadeguato”.
Punti chiave
- Gorelli denuncia l’elitismo del settore vino: unico comparto che giudica negativamente il consumatore senza competenza tecnica.
- La conoscenza usata come arma allontana i consumatori: carte vini intimidatorie spingono verso cocktail più immediati e accessibili.
- Democratizzare non significa banalizzare: rendere il vino accessibile preservando qualità e complessità, senza erigere barriere culturali.
- Il settore è ancora autoreferenziale: molte aziende parlano al vino e ai tecnici, non ai consumatori reali e potenziali.
- Serve un nuovo patto: il vino deve raccontare storie ed emozioni, non educare, diventando compagno di viaggio inclusivo.