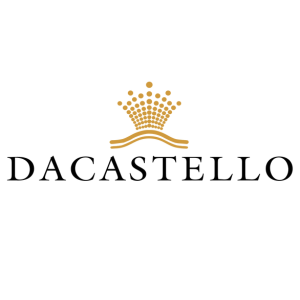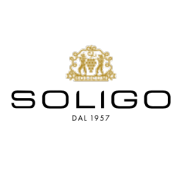Daniele Piccinin, imprenditore visionario, ha trasformato l’azienda agricola Le Carline puntando su viticoltura biologica, vini vegani e varietà resistenti. Con innovazioni sostenibili e certificazioni pionieristiche, Piccinin ha conquistato mercati internazionali, anticipando tendenze come il biologico e il vegano. Questo articolo esplora la sua storia, le sue strategie e la sua visione per il futuro del vino.
Indice
- Dalla carne al vino
- Perché non biologico?
- Verso la Cina con furore
- Oltre il biologico c’è di più
- Vini naturali sì o no?
- Certificatite?
- Potevano mancare i piwi?
- Strada facendo
Lasciamo perdere il vino filosofale, quello che sta nel mondo delle idee, immaginario, etereo. Quello del produttore che vive di uno spontaneismo catartico, quasi fanciullesco, integrale; che non guarda ai mercati e ai consumi, che non punta al profitto quasi fosse sterco del diavolo.
Daniele Piccinin e la sua azienda “Le Carline” di Pramaggiore (Ve) ne sono sempre stati lontani.
Hanno inseguito da sempre, ostinatamente, la maggiore qualità nei vini prodotti negli anni ma con lo sguardo lungo dell’imprenditore che programma e guarda ai mercati mondiali sapendo di dover raggiungere obiettivi di bilancio concreti; quelli che pagano le bollette, gli investimenti, i fornitori e gli stipendi dei dipendenti.
Perché se ti misuri col mondo devi avere la sagacia di guardare con gli occhi e degustare con naso e palato dell’asiatico, del latino americano, dello statunitense, del canadese, del tedesco e avanti. Devi saperne gli usi e i costumi, i gusti, le aspettative.
Daniele su questo è stato precursore, determinato, visionario sin da ragazzo. Incontenibile nella sua voglia, nella sua ambizione di misurarsi col mondo e con le sue regole, i suoi cavilli e le sue opportunità. Incontenibile sin da giovane, costantemente con lo sguardo lungo e ampio, rivolto al futuro, rivolto alla luna e non al dito.
Quando ha iniziato a muovere i primi passi nell’azienda agricola di famiglia, mentre i familiari pensavano ai cereali lui puntava alla carne; quando hanno iniziato a considerare la carne lui già puntava al vino; quando hanno capito l’importanza del vino lui era già proiettato al biologico; quando hanno iniziato a capire le opportunità del biologico lui già vedeva quelle del vegano e delle varietà piwi.
Una frenesia positiva, ostinata, spesa nei consorzi di produzione, nelle strade del vino, nella politica di categoria, nelle istituzioni, nelle sperimentazioni portate avanti con gli enti di controllo, i centri di ricerca e le università. E in mezzo un su e giù vorticoso nei Paesi più lontani, nei mercati più appetibili, competitivi e affamati di Made in Italy.
Dalla carne al vino
La prima partita iva di Daniele Piccinin è del 1986 quando, proveniente dal settore della meccanica, entra ufficialmente nell’azienda familiare gestita dal padre Aurelio e dallo zio Luigi.
Di origine friulana, i Piccinin sono arrivati a Pramaggiore nel 1959, direttamente dalla Svizzera dove erano emigrati, e hanno acquistato tre ettari di terreno dove avviare la tipica azienda agricola di queste zone: metà zootecnia da latte, metà cerealicoltura e qualche vigneto.
Le femmine di bovino venivano portate in lattazione e i maschi che nascevano venivano venduti dopo otto giorni ricavandone un guadagno discreto. Il mutuo quarantennale per l’acquisto del fondo comportava una rata mensile di 180000 lire che era il prezzo del vitello più bello venduto nell’anno. “Sono aneddoti che aiutano a capire l’evoluzione dell’azienda agricola” evidenzia Daniele.
“Quando sono arrivato io – continua – che ho sempre avuto la passione per la contabilità e i bilanci, mi sono chiesto perché vendere i vitellini? Immaginavo potesse essere più redditizio occuparsi anche dell’ingrasso per poi vendere la carne. E così, ascoltandomi, abbiamo fatto: si portava il vitello ingrassato a macellare qui vicino, si divideva in quattro quarti anatomici ognuno suddiviso in bistecche, carne da bollito, quinto quarto, ecc. e si vendeva alle famiglie della zona. Una sorta di ppl (piccola produzione locale) ante litteram”.
Il vitello ingrassato si vendeva a 600.000 lire; macellandolo anche con 30-40% in più di valore. Da ventidue vacche da latte nascevano 7 maschi all’anno. “All’epoca il latte rendeva veramente poco. Si riusciva a restare a galla e garantire una discreta redditività trattandosi di azienda a conduzione familiare dove le materie prime foraggere e cerealicole si producevano in casa e non si metteva in conto tutte le tante ore di lavoro. Perché mi hanno ascoltato sull’ingrasso? Mio padre non era molto d’accordo perché era un appassionato di animali. Mio zio invece mi ascoltava. A proposito di vino, che vendevamo sfuso in Piemonte e Lombardia, quando gli ho dimostrato che con una damigiana di vino pagavamo la rata del mutuo e un ettaro di terreno me ne garantiva duecento, mentre con la stessa superficie ingrassavamo non più di otto vitelli maschi, si sono nuovamente ravveduti sul mio conto. Non c’è proporzione riguardo alla redditività di quell’ettaro”.
All’epoca disponevano di due ettari e mezzo di vigneto dedicato a tocai e merlot lavorato tutto a mano e con una concimazione di solo letame di bovino altrimenti i costi sarebbero stati eccessivi. Gestione familiare e vinificazione arcaica tradizionale. Vini piuttosto longevi, strutturati ed alcolici. “Il passaggio successivo è stato quantificare la mole di lavoro necessaria alla gestione della stalla rispetto alle attività in vigneto e cantina. Ne risultò che su vite e vino si lavorava un decimo rispetto alla zootecnia e ottenendo la stessa plv (produzione lorda vendibile). Li è scattata la molla con mio padre timoroso e prudente ed io entusiasta e visionario. Pian piano è aumentata la produzione fino al 1986 quando ho aperto la partita iva e sono entrato in azienda deciso ad aumentare la superficie vitata fino a raddoppiarla rispetto agli esordi. Si facevano vini buoni, di pronta beva, che non costavano tanto a differenza dei prodotti veronesi e piemontesi. Ma soprattutto li vendevamo tutti. Un po’ alla volta abbiamo acquistato altri terreni e strutturata l’azienda. Ero fidanzato con Diana da sette anni e le dissi “o ci sposiamo subito o dopo, avviata l’azienda, non so se ne avrò il tempo”. E così mi sono tolto dalla vecchia società, abbiamo abbattuto la stalla zootecnica per passare ad azienda agricola specializzata, processo che all’epoca era finanziato, e mi sono sposato. Nel 1989 la prima vendemmia. Non è stato facile: poco più che vent’enne e pieno di debiti. Però, avevo una visione. All’epoca oltre allo sfuso che vendevo in Piemonte e Lombardia facevo il merlot e tocai per una nota azienda locale perché a loro giudizio la zona era vocata e il risultato più che lodevole. Verso la metà degli anni novanta resomi conto che con lo sfuso non si guadagnava poi così tanto ho pensato di imbottigliare e di dare un nome di fantasia all’azienda, pratica non così diffusa all’epoca”. Sono nate Le Carline.
Perché non biologico?
Già nel 1986, con l’allora agronomo della provincia di Venezia, Daniele iniziò a ragionare sull’opportunità di imboccare il percorso di conversione verso la conduzione biologica.
Un’encomiabile motivazione ambientale e sulla presunta qualità finale del prodotto o, soprattutto, interesse commerciale? “Purtroppo avevamo avuto grossi problemi di salute in famiglia dagli anni ottanta. Questa è stata la molla per convincermi di quanto fosse opportuno vivere in un ambiente più salubre per quanto possibile. I nostri padri erano abituati a mescolare con le mani prodotti di sintesi che poi venivano sparsi con trattori senza cabine chiuse e climatizzate. Mi sono persuaso da subito della necessità di salvaguardare me, chi viveva attorno a me e insieme anche chi consumava il mio prodotto.
Certo, bisognava capire come fare in un periodo in cui quasi nessuno produceva in regime biologico. La parola quasi non esisteva per quanto fosse normale nel dopo guerra trattare la frutta con poltiglia bordolese. Eravamo nel 1989 ed era molto prima della legge di riferimento 2092 del 1991. All’inizio abbiamo fatto delle esperienze negative ma abbiamo anche capito che si poteva fare e che questo avrebbe potuto aiutarci a distinguerci dalla massa dei produttori: iniziavano ad esserci tanti vini e tante aziende e per questo abbiamo ritenuto opportuno provare a darci una veste originale per quanto possibile potendo raccontare qualcosa di diverso. Arrivata la legge di riferimento per i vini da uve biologiche noi eravamo già pronti e questo, tra l’altro, ci ha permesso di iniziare ad esportare all’estero dove il vino biologico incrociava già da tempo il favore dei consumatori in particolare nei Paesi del Nord Europa a partire dalla Germania.
Mi ricordo che il più grande importatore di vino biologico del mondo, quando siamo partiti noi con la prima certificazione, era fresco di scuola e venne da noi al Vinitaly con i sandali e la valigia di cartone. Molto informato e capace, assaggiava solo i vini biologici. Oggi è il più grande importatore di organic wines dal mondo per il mondo. In buona sostanza, siamo partiti in due disperati e poi ci siamo ritrovati con un buon gruppo di produttori biologici del Veneto Orientale: con 1500 ettari la più grande area a vigneto biologico del Veneto”.
Verso la Cina con furore
“L’Asia, in particolare con la Cina – sottolinea subito Daniele – sta invadendo l’Europa che ci piaccia o no. Un processo iniziato anche nel mondo del vino. Sono i quinti produttori al mondo e si stanno proponendo con bottiglie di qualità ancora largamente discutibile per quelli che sono i nostri standard ma molto competitive per quanto riguarda la fascia di prezzo.
Perché discutibili? A cavallo del 2015 e per qualche anno fino allo scoppio della pandemia, facevo sei viaggi in Cina all’anno. Ho visitato parecchie realtà ed ho spiegato il significato di vino biologico in parecchi contesti, anche nelle televisioni nazionali. Sono stato tra i primi a certificarmi OFDC (Organic Food Development and Certification Center of China) che è l’organismo preposto a rilasciare la certificazione biologica cinese per avere la quale ci vogliono due anni: un anno per il controllo di campagna e un anno per il controllo di cantina. Vengono a controllare direttamente, appoggiandosi all’ente di certificazione nazionale, nel mio caso Icea. Verificano secondo le loro metodologie di controllo, con parametri di valutazione diversi dai nostri, che il processo di produzione sia conforme a quello che hai dichiarato nella richiesta di certificazione e ai loro standard e poi si esprimono. Il sistema è complessivamente un po’ rigido ma per noi il risultato finale è stato che Le Carline ha potuto essere certificata OFDC potendo mettere sulla bottiglia un codice unifer (codice alfanumerico irriproducibile con le stringhe fornite da loro) che costa agli importatori 12 centesimi a bottiglia.
Bene, a quel punto ci hanno detto che a loro non interessava la certificazione. Volevano soltanto verificare che fossimo seri e in grado di lavorare per loro. Negli anni a venire avendo ottenuto le certificazioni prodotto vegano (Bio Vegan di Icea) e pure Equalitas (uno standard sul Vino Sostenibile che risponde alle esigenze del settore di dotarsi di uno schema condiviso, oggettivo e certificabile da un ente terzo) mi sono proposto di fargli valutare anche queste. Ma a loro non è mai interessato: aspetti che noi riteniamo secondari per loro sono importantissimi e viceversa.
Il covid, in seguito, ha massacrato il mercato cinese del vino anche perché lo stile di consumo è cerimonioso, legato ad eventi e momenti particolari. Quindi, un po’ abbiamo fatto più fatica per qualche anno ad arrivare da loro con le nostre bottiglie e un po’ sono diventati più bravi a vinificare un prodotto base, di primo prezzo, difficile per noi da bere.
Ma il loro approccio è metodico, pianificato sul medio e lungo periodo. La prima volta che dieci anni fa mi hanno portato a vedere il primo campo sperimentale di vigneto non capivo. Non vedevo nulla se non una distesa di verde. Mille ettari da collina a collinari. Da allora è cambiato il mondo: i loro vigneti hanno ancora spesso acini grossi come la nostra uva da tavola, produzioni folli, concimazioni e irrigazioni spinte e da qui la qualità ne viene meno.
La spiegazione su questo approccio agronomico l’ho avuta dal mondo universitario cinese col quale mi sono confrontato lungamente: devono avere quantità, con un prodotto che deve costare poco e devono poterlo bere in tanti. Loro puntano a produrre internamente l’80% del vino consumato e relegare il 20% all’ importazione di prodotti destinati ad acquirenti con maggiore disponibilità di spesa.
Per raggiungere questi obiettivi devono recuperare rapidamente spazi di competitività senza improvvisazione e con sguardo lungo che guardi a una o due generazioni oltre l’attuale classe dirigente. Un barricato di due anni con cinque anni di invecchiamento non arriveranno mai a farlo. Ricordo che nel 1997 su commissione della Mitsubishi ho creato il mio primo vino insiemi a colleghi del territorio di Lison poi esportato in Cina. Erano venuti giù in dieci. C’era quello che aveva i soldi, il politico, ed il resto erano tecnici della Mitsubishi dei quali ognuno aveva una competenza. Sono andati via da qua con quattro buste di nailon di terreno. Quando sono andato a trovarli avevano analizzato il mio terreno, spianato una montagna, piantato un vigneto e costruito una cantina. Cosa mancava a quella terra rispetto alla mia? Tanti elementi. Come fare per integrarli? La loro risposta fu integrarli trovandoli in chimica, nessun problema. Risultato? Il vigneto non funzionava. Quindi? Serve anche sostanza organica? Nessun problema, distribuiamo anche quella. Morale della favola, a forza di tentativi e studi il risultato è arrivato. Non di qualità per come la intendiamo noi, ma è arrivato. Loro imparano. Hanno spedito la loro gente fuori, nel mondo, Africa compresa dove creano oasi, centri urbani e raccolgono materie prime e metalli che servono alla loro industria. Sono macchine da guerra che non fanno niente a caso e non c’è spazio di dissenso o iniziativa privata. Da loro tutto quanto entra in dogana viene controllato e se non è a posto non entra”.
Oltre il biologico c’è di più
“Proprio per questo mio guardare sempre avanti, siamo stati tra i primi a certificare il vino vegano. Cosa c’entra viene da chiedersi essendo tutto il vino vegano per definizione? Non è così! Ad esempio quando si utilizzano prodotti di origine animale per il processo di chiarifica. Sotto il profilo qualitativo del vino non credo ci sia una grande differenza tra vegano e non. E anche il costo, pur utilizzando prodotti di origine vegetale, cambia di poco. Tuttavia ci ha aperto un mondo. Una sera ero ad una cena di lavoro a Milano e con noi c’era la presidente nazionale dell’associazione vegetariani e vegani. Era seduta di fronte a me e non volle bere vino in quanto non ce n’era di vegano certificato. Li mi è nata l’idea. Il giorno dopo avevo già contatto l’Aiab e l’Icea e a breve mi confrontai con i loro ispettori accorgendomi che non c’era un protocollo definito e certificato per la produzione di vini vegani. Cosa facciamo? Lo abbiamo creato eliminando tutte le pratiche e le lavorazioni inadeguate ai fini dell’ottenimento di un vino vegano. Oggi la certificazione vegana volontaria, non obbligatoria, è più utilizzata di quella biologica. La più utilizzata in Europa è quella della Vegan Society: con 600 dollari ci si può autocertificare. Certamente nel mondo, ad esempio in Asia, se hai un ente terzo che ti certifica sei più credibile e vendi di più. In ogni caso a noi questo percorso ci ha permesso di entrare nella ristorazione specializzata di fascia molto alta. Le certificazioni vegane ad oggi sono molte di più di quelle biologiche. E molti dei certificati sono produttori convenzionali. È di moda dire vegano e in ogni caso un imprenditore serio e coerente deve dare possibilità di scelta al consumatore senza sindacare.
Vini naturali sì o no?
“Oggi hanno assunto molta importanza nell’immaginario collettivo dei consumatori. Li ho sempre criticati perché sono in autocertificazione e non controllati da un ente terzo. Chi lo fa seriamente dovrebbe non fare nulla come nella biodinamica, percorso, quest’ultimo, al quale mi sono avvicinato dieci anni fa. Io sono una persona concreta e quello che mi si dice deve essere dimostrato. Noi, ad esempio, molte pratiche biodinamiche in vigneto le portiamo avanti da decenni perché funzionali al nostro obiettivo di viticoltura. Sono scettico sul fatto che si debba pagare una royalty sulla propria produzione per poter utilizzare il certificato demeter che in Italia è poco conosciuto a differenza di quello tedesco e francese che è conosciuto da tutti. Ho insistito molto su questo ma siamo ancora lontani. Diciamo che a Le Carline abbiamo mantenuto tutte le pratiche importanti del biodinamico che hanno un senso sotto il profilo agronomico”.
A metà anni Ottanta nasce Naturasì, con l’esigenza principale di proporre ai propri consumatori un vino di qualità a prezzo competitivo e privo di allergeni, solfiti in particolare.
“Il primo nostro vino prodotto senza solforosa aggiunta risale a quattordici anni fa. Parliamo del Refosco dal peduncolo rosso, il nostro vino più conosciuto ed acquistato ad oggi. Oggi abbiamo cinque vini in distribuzione vinificati senza solforosa aggiunta. È stata certamente una scelta di mercato ma anche l’opportunità di conoscere fino a dove potevamo spingerci in questo senso. Diciamo che facendo un buon lavoro in campagna, aspetto che pesa per il novanta per cento nel raggiungimento del risultato finale, facendo una cernita delle migliori uve, usando lieviti indigeni e facendo un lavoro maniacale in cantina, di pulizia innanzitutto, si può arrivare a produrre vini senza solfiti di ottima qualità.
Lo testimonia il fatto che ad oggi stiamo commercializzando un vino senza solfiti di oltre tre anni. Agronomicamente è gestito tutto in regime di agricoltura biologica. Poi per fare la tipologia di vino senza solfiti scegliamo tra uve perfettamente sane. Il Dogale (verduzzo) e il Rosso Le Carline (refosco), per dire, escono solo nelle annate dove l’uva è perfetta”.
Complessivamente la selezione senza solfiti è il 20% del totale dei vini prodotti e non destinata a crescere. “Abbiamo adottato un sistema per cui lavoriamo in atmosfera modificata da dopo la fermentazione fino alla bottiglia e quindi lavoriamo in assenza di ossigeno. Il limite europeo per poter mettere in etichetta la dicitura senza solfiti aggiunti è 10 mg/litro di anidride solforosa. Noi siamo arrivati a produrre il refosco che ha 1 mg di totale. Personalmente sono stato uno di quelli che al Ministero ha dato battaglia per arrivare alla dicitura in bottiglia “senza solfiti aggiunti” perché anche pochissimi residui possono dare problemi agli allergici”.
Certificatite?
“Nel nostro percorso di quarant’anni ogni volta sentivo parlare di una certificazione in grado di avvalorare la qualità del nostro lavoro io ho sempre detto facciamola. La ragazza che segue le certificazioni mi odia. Il fatto di impostare il nostro lavoro perché sia sostenibile ambientalmente significa avere attenzione anche perché lo sia economicamente. E non significa solo guadagno per l’azienda ma soprattutto stipendi adeguati così come tutte le condizioni del lavoro e anche il giusto prezzo per il consumatore. Quando ho fatto la certificazione equalitas che teneva conto dei tre pilastri della sostenibilità noi eravamo non solo già pronti, ma già oltre. Le certificazioni sono incombenze? Chiedono un sacco di tempo? Si, ma ti insegnano a migliorare e a tenere in ordine l’organizzazione e la qualità del tuo lavoro; a raccontare cosa c’è dietro una bottiglia inteso come lavoro di un’azienda, di una comunità, di un Paese”.
Tante, troppe cose da comunicare al consumatore per una sola etichetta?. “Il rischio è sempre quello di riportare in etichetta troppe informazioni che possono confondere il consumatore. Soluzione? Siamo stati tra i primi a mettere in retroetichetta un qrcode. Una scoperta che feci oltre vent’anni fa durante un viaggio in Giappone. Arrivato a casa ho fatto la prima bottiglia col qrcode. Oggi come oggi, con le ultime disposizioni sull’etichettatura dei vini (informazioni nutrizionali, ingredienti e smaltimento rifiuti) il sistema qrcode si è rivelato l’unica soluzione possibile per riportate tutte queste informazioni.
Potevano mancare i piwi?
“Nel 2014 io e il funzionario regionale Giuseppe Catarin, una grande risorsa per il mondo del vino veneto a cui dobbiamo tutti moltissimo e purtroppo mancato qualche anno fa, siamo andati ad assaggiare delle microvinificazioni prodotte da vitigni resistenti che avevano l’ambizione di rappresentare i vini del futuro.
Si voleva avviare una sperimentazione con alcune varietà piwi e per questo mi sono messo a disposizione. Abbiamo costruito assieme un progetto pubblico – privato declinato da Veneto Agricoltura. Io ho messo la conduzione e il terreno dove nel 2014 abbiamo messo a dimora 35 varietà di viti fornite dai Vivai Cooperativi Rauscedo e da Vivai Trentini, comprensive di alcune tipologie sperimentali non registrate.
La parte pubblica ha fornito le barbatelle e le autorizzazioni e l’uva risultante veniva conferita per la microvinificazione a Veneto Agricoltura. Sul vino rimanente mi veniva concesso di tentare la vendita sul mercato. Abbiamo portato in registrazione 24 delle 36 varietà cosa che ha dato al Veneto il primato in Italia. E ad oggi siamo in fase di registrazione di altre due varietà e ne abbiamo messo in sperimentazione altre 5.
Adesso in Veneto ci sono più di 500 ettari vitati a piwi per 126 etichette che girano nel mondo. A fine dicembre 2023 abbiamo chiuso il percorso costitutivo e fondato l’associazione Piwitalia il cui statuto è stato costruito in armonia con quello di Piwinternational. Tutto il lavoro e la sperimentazione costruita con Veneto Agricoltura sono stati sfruttati da Le Carline per andare “oltre il biologico” che è diventato un brand di nostra proprietà che abbiamo registrato. Dapprima siamo partiti con due versioni, un bland di bianco e uno di rosso selezionando otto varietà a bacca bianca e otto a bacca nera. È nata così una linea produttiva dal nome Resiliens uscita in commercio per la prima volta nel 2017. Complessivamente abbiamo capito che sono viti che possono dare qualcosa di più per resistere ai cambiamenti climatici e che possono essere interessanti per il nostro areale. Attualmente abbiamo sei ettari a piwi, in aumento”.
Strada facendo
Visto i risultati raggiunti si sente di poter dire di aver avuto più o meno ragione rispetto al percorso imprenditoriale imboccato? “Tendenzialmente più ragione, ma col senno di poi credo che avrei potuto osare ancora di più. Mio padre non ha avuto il tempo di riconoscermi questa visione, la mamma sì. Osare di più nel senso di fregarmene di avere da subito la soddisfazione economica anche non essendo capito dai colleghi e soprattutto dai consumatori. Oggi mi sento di dire spesso ai miei figli Alessandro e Claudia, entrati recentemente in società, che se hanno un’idea e un percorso in mente, beh, devono imboccarlo; devono perseverare anche con la mia eventuale contrarietà. Tendenzialmente chiedono il mio parere, ma di solito sono più veloce io e tendo ad esprimermi ancora prima che mi venga chiesto… Una critica sul nostro operato? Forse stiamo facendo troppe cose. In tutto questo il ruolo di mia moglie Diana è ed è sempre stato determinante: è la moderatrice delle mie centomila idee ed è stata brava negli anni a contenere i miei eccessi di entusiasmo. Cosa che adesso sta facendo mio figlio, enologo bravo e metodico. La figlia ha un po’ più il mio carattere impulsivo”.
Il problema più complesso riscontrato in questi anni è stata la difficoltà a trovare manodopera disposta a lavorare in campagna. “E non riesco a capire come sia possibile nonostante tutti i disoccupati o inoccupati che ci sono. Temo manchi un po’ la volontà di mettersi in gioco”.
Cosa vede nel settore vino tra dieci o vent’anni? “Io vedo che l’agricoltura si sta concentrando attorno a proprietà sempre più grandi e specializzate. E dico per fortuna così come è una fortuna la progressiva scomparsa dell’agricoltura part time. Avremo uno spaccato netto tra la cooperazione specializzata nella produzione di vini di pronta beva, onesti e a prezzo di mercato e l’insieme delle aziende private, destinate ad ingrandirsi, specializzate in vini legati al territorio.
Io non potrò mai fare la concorrenza alla cooperazione sul prezzo: lì il costo è industriale ed il mio artigianale. Il singolo si deve specializzare su determinate nicchie e deve cercare e coltivare il segmento di mercato giusto per la sua nicchia. E poi sono convinto che il futuro della viticoltura sarà di vitigni resistenti ottenuti per incrocio, impollinazione o altro. Ed è per questo che ho voluto anche il CREA dentro a Piwitalia. È manipolazione genetica? Non sta a me dirlo, io non sono genetista.
Ma il problema sollevato da chi avversa questo sistema dovrebbe essere risolto non impedendo gli studi, le sperimentazioni e le autorizzazioni ma chiedendo di porre degli argini, dei limiti, se motivati. È un sistema destinato ad imporsi. Non sarà immediato ma sarà così perché è necessario dare al viticoltore la possibilità di resistere ai cambiamenti climatici innanzitutto e di lavorare assecondando i principi della sostenibilità.
E poi dobbiamo imparare sempre di più a raccontarci. Il Veneto ha al suo interno delle ricchezze uniche. Lo dicevamo con Giorgio Salvan vent’anni fa quando entrambi eravamo presidenti delle strade del vino di riferimento: o leghiamo al prodotto vino una storia da raccontare ancorata alle bellezze artistiche e alle peculiarità paesaggistiche e culturali del territorio di riferimento, arrivando al turismo o per il vino non ci sarà futuro. I vini entry level, così come in Cina, se li faranno direttamente gli Stati in cui poi saranno consumati.
Noi dobbiamo arrivare pronti ad arricchire l’offerta con i nostri vini di qualità in grado di raccontare ed evocare un territorio. Un Refosco del Lison Pramaggiore non avrà niente a che fare con un Bardolino per diversi motivi. Diverso è il vino e diverse le esperienze che si possono raccontare, evocare e fare solo in un determinato posto, in un determinato contesto che diventa eccellenza, esclusività. Un vino buono bevuto in un contesto piacevole, intrigante, di benessere, diventa ancora più buono e quindi prezioso e competitivo. Il vino è un’esperienza che dobbiamo spiegare, garantire, e far vivere in maniera adeguata”.
Leggi anche: Fausto Maculan: pioniere del Torcolato, simbolo di Breganze
Punti chiave
- Daniele Piccinin ha guidato Le Carline verso viticoltura biologica e innovazioni sostenibili.
- Pioniere del vino vegano certificato, ha introdotto protocolli specifici per la produzione.
- Promuove varietà resistenti per adattarsi ai cambiamenti climatici e garantire sostenibilità.
- Ha sfruttato certificazioni per raccontare il valore dei vini sul mercato internazionale.
- Crede nella combinazione di qualità e narrazione per rendere il vino un’esperienza unica.
Frequently Asked Questions – FAQ
1. Chi è Daniele Piccinin e qual è il suo contributo alla viticoltura?
Daniele Piccinin è un viticoltore visionario che ha trasformato l’azienda Le Carline puntando su biologico, vegano e vitigni resistenti.
2. Quali certificazioni hanno caratterizzato l’azienda Le Carline?
Le Carline ha ottenuto certificazioni biologiche, vegane e Equalitas per sostenibilità, distinguendosi nel mercato globale.
3. Perché Daniele Piccinin promuove varietà resistenti (PIWI)?
Le varietà resistenti permettono una viticoltura sostenibile, adattandosi ai cambiamenti climatici e riducendo l’uso di trattamenti chimici.
4. Come Le Carline ha sfruttato il mercato asiatico?
Piccinin ha certificato i vini per il mercato cinese, anticipando le richieste di consumatori attenti al biologico.
5. Quali sono le innovazioni di Le Carline oltre il biologico?
Le Carline ha introdotto vini vegani certificati e sviluppato protocolli per produzioni senza solfiti, rivolgendosi a nicchie di mercato.