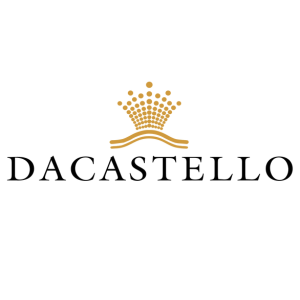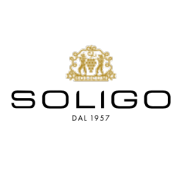Nel confronto tra identità territoriale e mercati globali, le reti d’impresa emergono come uno strumento pragmatico per il vino italiano, “l’unica strada realistica” secondo Flavio Geretto. Dalla promozione in Asia alla logistica, dalla comunicazione territoriale all’accesso ai fondi OCM, Geretto ragiona in termini di vantaggi misurabili, non di principi astratti.
Nel vino italiano convivono due anime apparentemente inconciliabili: da una parte l’identità territoriale, l’artigianalità, la forza delle storie familiari; dall’altra la necessità di confrontarsi con mercati globali che chiedono continuità, massa critica, investimenti strutturati. È in questo spazio di tensione che si colloca il dibattito sulle reti d’impresa, spesso percepite con diffidenza da un settore storicamente frammentato e individualista.
Flavio Geretto, Direttore Commerciale con esperienza diretta sui mercati internazionali, condivide uno sguardo funzionale e pragmatico. Non si tratta di buone intenzioni o di retorica collaborativa: si tratta di capire se esiste uno strumento concreto per affrontare sfide che da soli diventano insostenibili. Dalla promozione in Asia alla logistica, dalla comunicazione territoriale all’accesso ai fondi OCM, Geretto ragiona in termini di vantaggi misurabili, non di principi astratti.
Emerge un’idea precisa: la rete funziona quando agisce sul terreno comune – il territorio, la credibilità collettiva, gli investimenti condivisi – lasciando alle singole aziende lo spazio per esprimere la propria differenza. Non è questione di rinunciare all’identità, ma di creare le condizioni perché quella identità possa davvero contare. Perché, come dice Geretto, oggi “da soli si fa fatica”, soprattutto quando il primo ostacolo non è vendere una bottiglia, ma far percepire che quel territorio merita attenzione.
La vera domanda, allora, non è se le reti d’impresa siano uno strumento valido. È se i produttori italiani sapranno riconoscere che restare competitivi – senza tradire la propria autenticità – richiede nuove forme di collaborazione. E che il rischio più grande, forse, non è perdere qualcosa, ma rimanere invisibili.
Il mondo del vino italiano è storicamente caratterizzato da una certa frammentazione e da individualismo imprenditoriale. Cosa frena davvero i produttori dal “fare rete”: è più la paura di perdere identità, la difficoltà nel trovare partner con cui condividere una visione comune o sono altre le motivazioni?
Il vino italiano nasce da una storia di imprese familiari, identità forti e territori molto caratterizzati. Questo è un valore enorme, ma a volte diventa anche un freno: l’idea di mettersi in rete viene percepita come una rinuncia, come se collaborare significasse perdere autonomia o “diluire” la propria identità. Poi c’è la difficoltà concreta di trovare partner con cui condividere davvero una visione: non basta essere vicini geograficamente, bisogna essere compatibili per approccio, obiettivi e stile.
Detto questo, secondo me c’è un elemento ancora più sottovalutato: spesso manca proprio la conoscenza di cosa una rete d’impresa possa garantire anche alla singola azienda. Il “contratto di rete”, ad esempio, nasce proprio per permettere collaborazione su progetti e obiettivi comuni mantenendo indipendenza. Se questo concetto fosse più compreso, molte resistenze si ridurrebbero. Perché quando capisci che la rete più che un contenitore “politico”, rappresenta uno strumento pratico per fare cose che da soli non riesci a fare, cambia il modo di guardarla.
Le reti d’impresa vengono presentate come risposta ai paradossi del mercato: autenticità territoriale da un lato, competizione globale dall’altro. Secondo lei, questo equilibrio è davvero possibile o rischia di essere solo una bella teoria?
Secondo me non è teoria: è l’unica strada realistica. Oggi il mercato chiede autenticità, sì, ma chiede anche capacità di stare “in grande”: continuità, presenza, investimenti, capacità di comunicare e presidiare i canali. Se restiamo solo sull’autenticità, senza struttura e massa critica, rischiamo di essere invisibili fuori dal nostro perimetro. Se invece puntiamo solo sul volume senza radici, perdiamo ciò che ci rende unici.
Ecco perché l’equilibrio è possibile, anzi necessario: per valorizzare davvero un territorio o un prodotto con caratteristiche specifiche, serve massa critica che renda quel racconto credibile e competitivo nel mondo. La rete può aiutare in modo determinante proprio in questo: dare numeri, forza e importanza per “contare” a livello globale, senza impedire alle singole aziende di esprimere la propria personalità.
Se dovesse immaginare una rete d’impresa ideale per il settore vinicolo, quali caratteristiche dovrebbero avere le aziende partner per creare davvero valore condiviso e non solo buone intenzioni?
La prima cosa è condividere i valori. Bisogna partire da un’idea comune su come interpretare il prodotto, il territorio e il mercato: non serve essere uguali, ma serve avere la stessa direzione. Se non c’è comunione di intenti, la rete diventa una somma di interessi individuali e si blocca appena arrivano le prime scelte difficili.
Poi serve chiarezza: la rete deve occuparsi in modo unitario degli aspetti istituzionali e strategici – comunicazione, posizionamento territoriale, progetti comuni, strumenti – lasciando però alle aziende lo spazio per produrre, raccontare e vendere secondo le proprie filosofie. Una rete funziona quando agisce sul terreno comune e lascia liberi i singoli sul distintivo. E deve essere anche concreta: obiettivi misurabili, ruoli, budget e responsabilità.
Una delle sfide maggiori è superare la logica del “mio” per abbracciare quella del “nostro”. Dal punto di vista commerciale, cosa significa concretamente per un’azienda vinicola condividere strategie, mercati o strumenti promozionali?
Commercialmente significa partire da una verità che, oggi più che mai, è evidente: da soli si fa fatica. Soprattutto quando devi introdurre un prodotto o un territorio e creare un’esigenza nel mercato. Il primo ostacolo, spesso, non è vendere una bottiglia: è far percepire che quel territorio, quel vitigno o quello stile meritano attenzione. E per creare attenzione servono forza, continuità e investimenti.
La rete può servire proprio a questo: far capire che esiste un territorio, che c’è un’identità collettiva, che ci sono più aziende che lavorano seriamente nella stessa direzione. Una volta che la rete ha creato questo “spazio mentale” nel trade e nel consumatore, allora ognuno può giocare la propria partita dentro quello spazio, con la propria differenza. Inoltre, lavorare in rete rende più facile strutturare progetti comuni anche dal punto di vista dei contributi e delle attività promozionali, perché si ragiona con numeri e programmi più solidi.
Le cooperative hanno una tradizione consolidata di collaborazione. Ritiene che ci siano modelli cooperativi da cui anche le imprese private a gestione familiare potrebbero trarre ispirazione per costruire reti efficaci?
Le cooperative, nel bene e nel male, hanno una cosa che spesso alle reti “spontanee” manca: la disciplina del modello. Una cooperativa è, di fatto, un’unione di produttori che decide di avere un organo rappresentativo e una struttura, con regole e obiettivi. Questo aspetto è fondamentale: senza una struttura e senza regole condivise, la collaborazione resta fragile.
Le imprese familiari non devono diventare cooperative per imparare qualcosa ma possono prendere spunto su tre punti:
- governance chiara e decisioni rapide, senza ambiguità,
- servizi condivisi che alleggeriscono il lavoro del singolo (ad esempio progetti promozionali, strumenti commerciali, competenze),
- visione di medio-lungo periodo, perché i benefici di una rete non sempre si vedono in tre mesi, ma si costruiscono. In sostanza: metodo cooperativo, identità privata.
Logistica, promozione internazionale, digitalizzazione, sostenibilità: quale di questi ambiti ritiene possa beneficiare maggiormente di un approccio condiviso attraverso una rete d’impresa?
Direi che conviene su tutti questi fronti, per ragioni diverse. La logistica è un tema immediato: se hai prodotti con problematiche simili, ragionare insieme su spedizioni, consolidamenti, magazzini e condizioni può generare risparmi veri e anche un servizio migliore verso clienti e importatori.
La promozione internazionale è forse l’area più “potente” perché richiede investimenti continui e competenze, e perché può essere collegata a strumenti strutturati come l’OCM.
La digitalizzazione può essere affrontata con piattaforme condivise (contenuti, dati, strumenti), lasciando poi alle aziende la declinazione in base al proprio stile. E sulla sostenibilità è simile: se devi affrontare certificazioni, audit, consulenze e processi, farlo “a pacchetto” come rete spesso riduce costi e tempi.
La questione dell’identità è cruciale nel vino. Come si può garantire che entrare in una rete d’impresa non significhi diluire la propria unicità, ma effettivamente moltiplicarne il valore?
Qui la distinzione è fondamentale: le aziende non possono delegare a qualcun altro la propria unicità. L’unicità è ciò che fa scegliere un brand rispetto a un altro e va raccontata, difesa e sviluppata dall’azienda stessa. Però proprio per concentrarsi meglio su questa unicità, si possono delegare alla rete gli aspetti comuni e istituzionali: promozione del territorio, relazioni con opinion leader e stampa, attività corali, tutela di alcuni aspetti anche legali o organizzativi che, se gestiti insieme, costano meno e funzionano meglio.
Spesso la stampa e gli opinion leader oggi sono più propensi a raccontare territori e storie collettive, non solo “il brand”. Se la rete crea attrazione sul territorio e sul contesto, poi le aziende hanno più spazio e più occasioni per far emergere la propria differenza. In molte denominazioni, storicamente, è bastata l’azione di pochi produttori forti per trascinare tutti: una rete serve anche a distribuire meglio quello sforzo e renderlo più stabile nel tempo.
I mercati esteri più distanti – Asia, Nord America, mercati emergenti – richiedono investimenti significativi. Una rete orientata all’export può davvero fare la differenza o il rischio è creare solo un ulteriore livello di complessità burocratica?
Per me è un aiuto reale, a patto che la rete sia fatta bene. Girando il mondo ti accorgi di quanto sia difficile far percepire un territorio e, a volte, il vino stesso in mercati dove non è un’abitudine quotidiana, come alcune aree dell’Asia. Lì non devi solo “vendere”: devi educare, creare occasioni di consumo, formare il trade, costruire fiducia. È un lavoro di continuità e costo che da soli diventa quasi proibitivo.
La rete orientata all’export può davvero fare la differenza perché permette un’azione condivisa, più credibile e più continuativa. Il rischio di burocrazia esiste quando la rete è solo un livello organizzativo aggiuntivo senza deleghe chiare. Ma se c’è una struttura che gestisce bene progetti, strumenti e magari anche iniziative finanziate, allora la rete semplifica invece di complicare. Fondamentale è la governance, cioè il soggetto individuato dai membri della rete per sviluppare i progetti, la quale deve avere le competenze, la reputazione, la fiducia, le capacità, la leadership e autonomie operative necessarie per tradurre i progetti in fatti concreti.
Ha mai assistito a esperienze di collaborazione, anche informali, tra aziende che le hanno fatto pensare “se questa cosa fosse strutturata meglio, potrebbe davvero funzionare”? Cosa mancava per trasformarla in una rete vera?
Sì, mi è capitato di vedere collaborazioni che funzionavano anche molto bene: aziende che condividevano contatti, fiere, opportunità, o facevano azioni comuni su un importatore o su un evento. Quando funziona, di solito c’è fiducia e c’è un obiettivo chiaro.
Quello che spesso manca è la strutturazione: compiti precisi, perimetro definito e soprattutto una gestione. Deve essere chiaro dove comincia la rete e dove finisce, e dove comincia l’azienda e dove finisce. E quando c’è una struttura, bisogna saper delegare a persone con esperienza, capaci di gestire criticità e di tenere la rotta anche quando emergono interessi diversi. Serve anche una convinzione profonda del vantaggio reciproco: se la rete è vissuta come “io do e non so cosa ricevo”, non regge; se è vissuta come investimento comune con ritorni misurabili, allora diventa solida.
Tra dieci anni, immagina un settore vitivinicolo italiano in cui le reti d’impresa saranno la norma o rimarranno un’eccezione per pochi? E cosa serve perché diventino davvero uno strumento diffuso?
È difficile dare una risposta netta, perché dipende dai risultati. Un modello si diffonde quando produce benefici tangibili: export più forte, costi ridotti, maggiore visibilità, accesso più facile a progetti strutturati, migliore capacità di presidio dei mercati. Se le reti che stanno nascendo oggi dimostrano risultati chiari, allora vedremo un effetto emulazione, e il modello diventerà più comune.
Io sono ottimista, soprattutto se le reti saranno “miste” e intelligenti, quindi capaci di mettere insieme anche mondi diversi – cooperative e privati – quando c’è un obiettivo condiviso. Il settore sta diventando sempre più competitivo, complesso e globale: in questo scenario, o ci si organizza meglio, o si rischia di restare piccoli non per scelta ma per limite. Le reti d’impresa possono diventare uno degli strumenti più concreti per restare autentici e, allo stesso tempo, competitivi.
Punti chiave:
- Le reti d’impresa non sono un compromesso identitario, ma uno strumento operativo per affrontare mercati sempre più complessi.
- La massa critica è indispensabile per dare credibilità internazionale ai territori senza annullare le singole differenze aziendali.
- Governance chiara e obiettivi misurabili sono la base per evitare burocrazia e conflitti interni.
- Promozione, export e logistica sono gli ambiti in cui la collaborazione genera benefici immediati e concreti.
- Il rischio maggiore oggi non è collaborare, ma restare invisibili in un mercato globale sempre più competitivo.