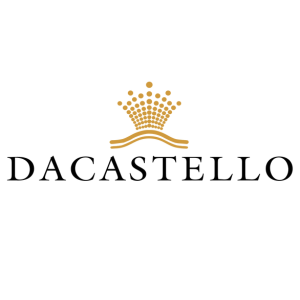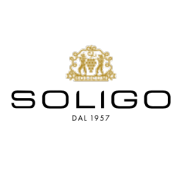I vini no-alcohol e low-alcohol tornano al centro del dibattito tra aspettative, tecnologia e sostenibilità. Da come nascono i dealcolati, al perché l’assenza di etanolo cambia struttura e aromi e perché la qualità, specie nei fermi, resta discontinua. Le bollicine reggono meglio. Mercato in crescita, ma comunicazione da rendere più onesta.
Nell’ultimo periodo il tema dei vini no-alcohol e low-alcohol è tornato con forza al centro del dibattito professionale. Lo dimostra anche il recente editoriale pubblicato su Wine Meridian dal nostro direttore Fabio Piccoli – Vini no alcol: molto rumore per (quasi) nulla -, che ha affrontato con lucidità e spirito critico il ruolo e le prospettive di questi prodotti nel panorama vitivinicolo contemporaneo.
In questo contesto si inserisce anche un approfondimento tecnico pubblicato da Wicproject.com, dedicato ai processi produttivi dei vini dealcolati e alle differenze sostanziali rispetto al vino tradizionale. La lettura di questo articolo cade quindi in un periodo particolarmente ricco di riflessioni e informazioni su una categoria che, nel bene e nel male, sta cercando di ritagliarsi uno spazio definito nel mercato e nel dibattito culturale del vino.
Dal punto di vista tecnico, il quadro è ormai piuttosto chiaro: nella maggior parte dei casi il vino dealcolato nasce come vino tradizionale, che viene successivamente sottoposto a processi di rimozione dell’etanolo (osmosi inversa, distillazione sottovuoto, colonne a cono rotante). L’alcol, tuttavia, non è soltanto un elemento “funzionale”, ma svolge un ruolo centrale nella struttura sensoriale del vino: veicola aromi, ammorbidisce l’acidità, contribuisce alla sensazione di volume e alla persistenza gustativa. La sua eliminazione comporta inevitabilmente una perdita di complessità e spesso richiede interventi correttivi, come l’aumento del residuo zuccherino, per rendere il prodotto più facilmente bevibile.
Questo aspetto tecnico è fondamentale per comprendere perché il vino dealcolato difficilmente possa essere considerato una semplice versione “più leggera” del vino tradizionale.
Sul piano dell’assaggio, la distanza resta evidente, soprattutto per i vini fermi. Acidità spigolose, squilibri gustativi, residui zuccherini marcati e una generale mancanza di profondità rendono ancora oggi difficile trovare prodotti davvero convincenti e continui dal punto di vista qualitativo.
Diverso il discorso per le bollicine analcoliche, che negli ultimi anni sembrano aver trovato una collocazione più naturale: complice la freschezza intrinseca dello stile, la presenza dell’anidride carbonica e una minore aspettativa di complessità, questi prodotti risultano spesso più immediati e godibili. Non a caso iniziano a comparire con maggiore frequenza nella grande distribuzione, in alcuni wine bar e in contesti ristorativi attenti alle nuove richieste del pubblico.
Ciò non significa che il problema sia risolto, ma indica che alcuni segmenti della categoria riescono oggi a dialogare meglio con il consumatore rispetto ad altri.
Al di là delle valutazioni sensoriali, è innegabile che il mercato dei vini no e low alcohol esista e stia crescendo, seppur partendo da volumi ancora contenuti rispetto al vino tradizionale. A livello globale si parla di un comparto in espansione, trainato soprattutto da Nord Europa, Stati Uniti e mercati asiatici, mentre in Italia il fenomeno resta marginale ma osservato con crescente attenzione.
In un Paese dalla fortissima identità enologica come il nostro, è comprensibile una certa diffidenza: il consumatore italiano tende a essere prudente verso le innovazioni che toccano prodotti simbolo della tradizione. Tuttavia, ignorare l’esistenza di questa domanda, per quanto minoritaria, sarebbe miope. Chi oggi investe in ricerca, tecnologia e posizionamento probabilmente lo fa anche in una logica di medio-lungo periodo, per farsi trovare pronto qualora il mercato dovesse maturare.
Un parallelo interessante può essere fatto con altri prodotti alimentari “innovativi”, come le alternative plant-based alla carne. Anche in quel caso si è assistito a una forte spinta iniziale, accompagnata da entusiasmo mediatico, promesse di sostenibilità e benefici per la salute, seguita spesso da critiche, talvolta fondate, talvolta eccessive, e da una parziale perdita di attenzione da parte del grande pubblico.
È una dinamica tipica di molte novità: prima l’hype, poi la fase di ridimensionamento, talvolta l’oblio. L’auspicio è che questo non accada ai vini no e low alcohol, ma che si arrivi piuttosto a una loro collocazione più stabile e consapevole, come categoria specifica e non come semplice “surrogato” del vino tradizionale.
Questo discorso si lega direttamente al tema della salubrità e della sostenibilità, spesso utilizzato come principale leva comunicativa. Così come per molti prodotti plant-based, anche nel caso dei vini dealcolati il processo produttivo è tutt’altro che semplice o “naturale”: richiede impianti complessi, consumi energetici rilevanti, utilizzo intensivo di acqua e risorse tecnologiche. Definirli automaticamente più sani o più sostenibili è una semplificazione che non regge a un’analisi completa del ciclo produttivo.
Il vino dealcolato non va demonizzato né idealizzato. È un prodotto che esiste, risponde a una richiesta reale, seppur limitata, ed è legittimo che produttori e operatori della ristorazione decidano di investirvi e proporlo in carta, così come è legittimo che molti appassionati continuino a preferire il vino tradizionale senza esitazioni.
La chiave sta nella comunicazione: presentare questi prodotti per ciò che sono, senza promettere esperienze identiche al vino con alcol e senza costruire narrazioni forzate sulla loro presunta superiorità etica o salutistica.
Solo in questo modo il segmento potrà trovare, se lo merita, una propria maturità. Il tempo farà il resto.
Punti chiave
- Processi produttivi: osmosi inversa, distillazione sottovuoto, cono rotante; il vino nasce “normale”, poi perde alcol.
- Ruolo dell’alcol: aromi, volume e persistenza; rimozione = minore complessità e spesso correzioni zuccherine.
- Qualità sensoriale: nei fermi emergono acidità spigolose e squilibri; continuità qualitativa ancora rara.
- Bollicine no-alcohol: CO₂ e stile fresco mascherano i limiti; più facili da accettare e in aumento nei locali.
- Sostenibilità e comunicazione: processi energivori; evitare promesse “più sano/più etico” e raccontare la categoria per ciò che è.