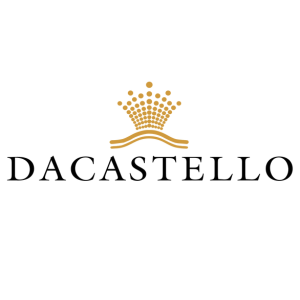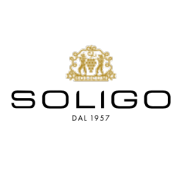La Svezia emerge come nuova, seppur piccola, regione vinicola. Con circa 200-250 ettari vitati , dominati da varietà PIWI come il Solaris e un’agricoltura simil-biologica, il paese sperimenta. Questa nuova frontiera è un adattamento ai cambiamenti climatici o un’ostinazione agronomica che forza i limiti del terroir?
Che la Svezia potesse diventare un paese vitivinicolo era, fino a pochi decenni fa, un’ipotesi relegata alla fantascienza agronomica. Eppure, oggi è una realtà. Sebbene parlare di “industria” sia prematuro, dato che attualmente si contano tra i 200 e i 250 ettari vitati, il paese non solo è riconosciuto come regione vitivinicola dall’UE fin dal 1991, ma negli ultimi anni ha visto un interesse crescente da parte di produttori ed enologi con un aumento di superficie vitata dai 15 ai 20 ettari l’anno.
Il contesto è unico e complesso: non esistono ancora indicazioni geografiche o denominazioni d’origine e tutto il vino prodotto viene etichettato semplicemente come “Vino dalla Svezia”.
Attualmente, la viticoltura svedese è definita da due fattori climatici e uno legislativo. La stagione di crescita è molto breve, con la fioritura che termina intorno al 20 giugno. Dopo la fioritura le piante godono di quasi 24 ore di luce diurna (il 20% in più rispetto a Bordeaux). Il fattore legislativo è determinante: il rame è vietato nell’agricoltura svedese. Questa scelta impone, di fatto, un approccio biologico e rende quasi obbligatorio l’uso di varietà resistenti. Non a caso, circa il 95% delle viti appartiene alla famiglia dei PIWI, che offrono la migliore possibilità di ottenere rese affidabili. Non a caso, il Solaris è la varietà più diffusa.
Oltre la tradizione: la vera domanda
Un recente articolo di Wein.Plus – Where good wine needs no tradition – introduce il tema della viticoltura in Svezia con un titolo provocatorio “Dove il buon vino non ha bisogno di tradizione”. Con questa apertura si pone, indirettamente, una domanda “Per fare un buon vino c’è bisogno di avere dietro una tradizione lunga secoli?”.
La risposta più ovvia, e corretta, è: no. L’esperienza è certamente un valore aggiunto, un patrimonio inestimabile di conoscenze pratiche. Ma per fare un buon vino non è necessaria. Un giovane produttore di trent’anni, senza decenni di esperienza alle spalle ma con studi solidi, formazione agronomica ed enologica avanzata e una visione chiara, può produrre vini eccellenti.
Concentrarsi solo sul tema della tradizione è furbo ma fuorviante, specialmente nel contesto svedese. L’emergere della viticoltura a queste latitudini pone un interrogativo diverso e, forse, più importante.
La vera domanda è: stiamo assistendo ai miracoli delle mutazioni climatiche o si tratta di qualcos’altro?
Un’analisi oggettiva suggerisce che la risposta stia nel mezzo, ma con una forte preponderanza del secondo fattore. È innegabile che il cambiamento climatico stia giocando un ruolo. Uno studio dell’Università di Lund ha stimato che in Svezia ben 5.000 ettari sarebbero adatti alla coltivazione della vite. È significativo, però, che queste aree siano identificate esclusivamente sulla costa e vicino al mare, poiché nell’entroterra il rischio di gelo aumenta in modo sproporzionato. Il riscaldamento globale sta evidentemente rendendo coltivabili aree prima impensabili.
Tuttavia, il clima da solo non basta. La viticoltura svedese, come la conosciamo oggi, è resa possibile principalmente dalla tecnologia agronomica, ovvero dai PIWI. L’uso del 95% di ibridi non è una scelta stilistica, ma una necessità dettata dal divieto di usare il rame e dalla pressione delle malattie in un clima comunque umido (700 mm di pioggia annui). Accanto ai PIWI, c’è chi sperimenta con coraggio varietà vinifera tradizionali come Pinot Noir Précoce, Chardonnay e persino Chenin Blanc, ma restano una minoranza.
Si tratta di una viticoltura che deve ancora “costruire” il proprio terroir. Il terreno deve essere letteralmente costruito, poiché in precedenza ospitava pascoli; non a caso, l’approccio più corretto per alcuni è la viticoltura rigenerativa.
Al di là dell’analisi tecnica e delle potenzialità di mercato (l’obiettivo è raggiungere 500-1.000 ettari per creare una “massa critica”), sorge una riflessione più filosofica sulla natura stessa della viticoltura.
È giusto forzare ciò che non è nato per essere?
L’utilizzo massiccio di ibridi, sebbene tecnicamente brillante e agronomicamente necessario in Svezia, rappresenta una forma di “forzatura” tecnologica. È l’uomo che, armato di genetica e spinto (o aiutato) dal cambiamento climatico, impone una coltura dove questa, naturalmente, non prospererebbe con tale facilità.
Se da un lato la tenacia e l’innovazione dei viticoltori svedesi sono ammirevoli, dall’altro questa nuova frontiera ci interroga su quanto sia sostenibile – non solo ambientalmente, ma culturalmente – spingere la vite così a nord, lontano dalle sue culle tradizionali, affidandosi a scorciatoie genetiche per vincere una battaglia contro la natura del luogo.
Punti chiave
- Il contesto svedese: Un’industria nascente (200-250 ettari) , non ancora regolamentata (assenza di DOP/IGP) e soggetta al rigido monopolio statale sull’alcol (Systembolaget).
- La scelta (quasi) obbligata dei PIWI: Il 95% delle viti piantate è costituito da varietà PIWI, essenziali per ottenere rese affidabili in un clima difficile e data la messa al bando del rame nell’agricoltura locale.
- Potenziale e crescita: Uno studio dell’Università di Lund indica un potenziale di 5.000 ettari idonei sulla costa. La crescita attuale è di 15-20 ettari l’anno, puntando alla “massa critica” di 500-1.000 ettari.
- La vera domanda: Il dibattito non è “tradizione vs. innovazione”, ma se questa viticoltura sia una risposta inevitabile al cambiamento climatico o una forzatura agronomica resa possibile solo dalla tecnologia (ibridi).