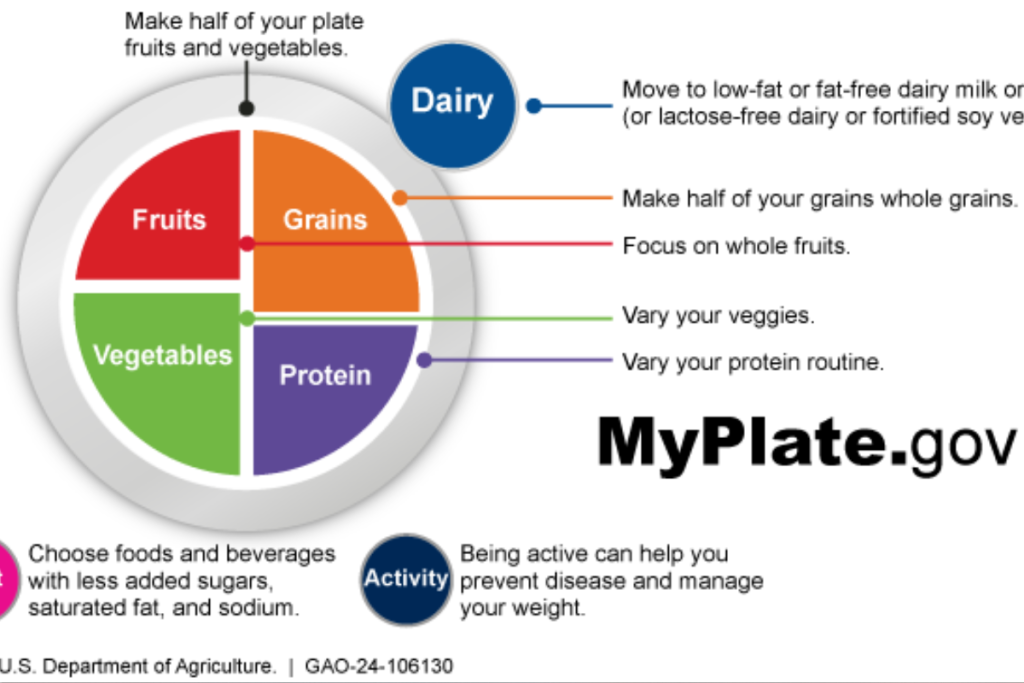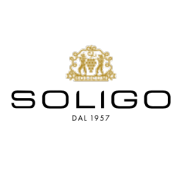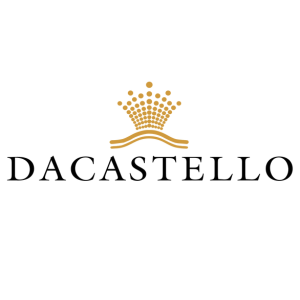In un’epoca dominata dalla fretta e dalle mode effimere, Mattia Vezzola sceglie la via della longevità, costruendo un rosé da viticoltura che è insieme progetto produttivo e visione culturale. Dalla Valtènesi al mondo, passando per sfide burocratiche e identità italiane da ricostruire, emerge il ritratto di un vignaiolo che invita il vino a prendersi il suo tempo.
In un mondo del vino sempre più condizionato dalla logica del “tutto e subito”, c’è chi decide consapevolmente di rallentare, di ascoltare il tempo e il territorio, e di fare del concetto di longevità un manifesto produttivo e culturale. L’intervista che segue è un dialogo approfondito e mai banale con Mattia Vezzola, titolare di Costaripa, un produttore che ha scelto di percorrere la strada meno battuta, quella che non si piega alle tendenze, che non rincorre il mercato con prodotti effimeri, ma che costruisce valore sulla base della vocazionalità e della coerenza.
Tra “rosé da viticoltura” e riflessioni sulla burocrazia europea, passando per un’analisi sul rischio di smarrire l’identità stilistica del vino italiano, emergono spunti di grande lucidità: dalla necessità di raccontare in modo efficace le identità geoclimatiche dei territori, alla consapevolezza che aprire le cantine al pubblico è un atto culturale e relazionale.
Emerge forte una visione: quella di un’Italia del vino che dovrebbe imparare a ragionare per macroaree riconoscibili e credibili, superando il campanilismo che spesso frammenta e indebolisce. Una visione che invita il sistema vino ad avere il coraggio di smascherare i propri equivoci più radicati e a investire nella memoria emozionale dei consumatori. Un’intervista che, più che risposte, offre chiavi di lettura. E stimola domande urgenti.
Le faccio una domanda un po’ sui generis: in un’epoca in cui si rincorre spesso la novità, lei ha scelto la longevità. È una forma di resistenza culturale, un atto ideologico o semplicemente una fede nella dimensione naturale del vino?
No, è che il vero valore del vino è legato alla sua capacità di vivere a lungo, proprio come la nostra vita. La nostra longevità dipende da come ci alimentiamo, studiamo, amiamo e viaggiamo. Lo stesso vale per la vigna. Una filosofia che porta in quella direzione è quella che mi dà soddisfazione, sempre che il territorio e la vigna siano in grado di esprimere quel valore, grazie a ciò che qualcuno definisce vocazionalità. Un territorio che, dopo centinaia di anni di esperienza, ti consente di intraprendere quel viaggio, proprio come una vita che si arricchisce con il tempo.
Ha spesso sfidato la percezione comune dei rosati come vini “semplici”. Qual è, secondo lei, un altro grande equivoco che il mondo del vino italiano dovrebbe avere il coraggio di smascherare?
Beh, è molto semplice: esistono due modi di fare un rosato. Uno è da uva e l’altro è da viticoltura. Tutti possono fare un rosé, ma pochi possono farlo dedicando 100 anni di esperienza sulla gestione viticola per produrre un frutto che abbia le caratteristiche ideali per questo vino. Un esempio pratico: il Pinot Nero dello Champagne e quello della Borgogna sono sempre Pinot Nero, ma sono biotipi molto diversi. In Champagne, la buccia è vista come un elemento negativo, mentre in Borgogna è un valore aggiunto per la produzione di un grande vino rosso. Per raggiungere questi risultati, mediamente servono 100 anni di lavoro da parte di tre generazioni. Quindi, un rosé che nasce da una viticoltura dedicata, come quella che io chiamo “rosé da viticoltura”, è qualcosa di molto serio. E le due uniche aree geografiche al mondo dove questo accade sono la Provenza e la Valtènesi.
La viticoltura della Valtènesi è figlia di una “enclave mediterranea” tra le Alpi. Quanto conta oggi saper raccontare l’identità geoclimatica di un territorio per renderlo competitivo a livello internazionale?
La vocazionalità è proprio quella: Dio ha creato quel luogo con la giusta condizione per fare un grande vino, come un grande radicchio o una ciliegia a Vignola. La vocazionalità significa che quel posto è naturalmente destinato a produrre qualcosa di unico. Tuttavia, è l’uomo che deve sapere come trasformare e interpretare la materia. A me piacerebbe che la zona del Lago di Garda, nei prossimi 20-30 anni, diventasse il simbolo in Italia della qualità dei rosé da viticoltura. I consumatori dovrebbero conoscere la differenza tra un rosé prodotto in quella zona e un rosé qualsiasi, proprio come un vino che proviene da una specifica tradizione viticola.
Lei parla spesso di “costanza e riconoscibilità” come valori produttivi. Ma oggi il vino italiano non rischia di rincorrere troppo la novità (vedi no/low alcohol) e perdere il senso del proprio stile?
Sì, io li chiamo “vini della disperazione”. Quando ti allontani dalla vocazionalità per rincorrere il mercato, rischi di inseguire per sempre il tuo bilancio. La vera differenza, secondo me, è quella di dedicare la propria vita a rappresentare la vocazionalità del territorio. Non è una questione di giusto o sbagliato, ma di vitale o mortale. Andare verso l’industria è mortale, perché non potrei mai fare un vino che costa 2 euro. L’industria non ha la capacità di interpretare la materia come un piccolo produttore. Bisogna essere chiari con il consumatore: quando compri un maglione di cashmere che si rovina dopo pochi lavaggi, sai che qualcosa non va. Dunque se l’hai pagato 100 euro è accettabile, ma se l’hai comprato a 1000 euro no. Il marketing serve anche a questo: a fare in modo che il consumatore capisca esattamente cosa sta comprando.
In un futuro segnato da cambiamenti climatici e incertezze, qual è secondo lei l’errore più grave che la viticoltura italiana potrebbe commettere nei prossimi anni?
L’errore sarebbe non gestire la viticoltura in modo da farla vivere a lungo. Una vigna, come noi, può vivere 100 anni se la curi con amore. Invece, molti produttori puntano solo sulla quantità e sulla produttività. Ma se il tuo obiettivo è la quantità, quando raggiungi i 60 anni, non riuscirai a continuare con la stessa intensità. Una vigna inizia a produrre uve di grande qualità dopo 20-30 anni, e nel momento in cui quella vigna sta dando il meglio, non puoi ripartire da zero. La potatura non deve essere fatta per produrre solo quantità, ma per garantire che la vigna viva a lungo, continuando a dare uve di qualità.
Cambiando tema e focalizzandoci sulla questione dei dazi USA, quanto pesa per la vostra azienda l’export negli Stati Uniti in valore e volumi? Avete già riflettuto su quali strategie intendete adottare per gestire la situazione nel caso in cui Trump riproponga i dazi dopo il congelamento che terminerà il 9 luglio?
Credo che ci vorranno alcuni mesi per riequilibrare la situazione. Come dicono gli orientali, non c’è niente di troppo positivo o troppo negativo. Il Padre Eterno ci ha dato l’intelletto per adattarci. Certo, i dazi preoccupano, ma quello che mi preoccupa di più è la burocrazia europea che limita la viticoltura e la vinificazione. Abbiamo 27 organi di controllo e il 40% delle risorse aziendali sono impegnate nella gestione burocratica. È assurdo. Ciò che conta è che il mercato globale sia pieno di opportunità, e se ci liberassimo da tutte queste catene burocratiche, potremmo competere meglio.
Volendo guardare il bicchiere mezzo pieno, è possibile che questa situazione di costante minaccia e incertezza ci costringa ad avvicinarci maggiormente ai Paesi BRICS o a chiudere definitivamente l’accordo con i Paesi sudamericani del Mercosur, oppure questo eventuale avvicinamento non andrà in ogni caso ad influenzare particolarmente il mercato del vino italiano ed europeo?
Questo potrebbe essere un momento per risvegliare le coscienze. Quando qualcuno ti mette fuori dalla porta, ti costringe a riflettere su chi sei veramente. È un’opportunità per essere più consapevoli del nostro valore, senza copiare nessun altro. Se siamo unici, possiamo farcela anche senza ricorrere alla concorrenza dei più economici. Bisogna essere autentici, e questo può solo portare valore.
341 vini DOC, 78 DOCG e 120 IGT: questi sono i numeri delle nostre denominazioni. Ma le 25 più grandi rappresentano oltre il 65% dei volumi ed oltre il 75% del valore. Lei ritiene che siano troppe e vadano ridimensionate oppure rappresentano la diversità e la ricchezza dell’Italia enoica?
È la legge di Murphy: il 25% fa il 75% del lavoro. Penso che l’ideale sia che ognuno mantenga la propria identità, ma raggruppato in macroaree. La Provenza ha sette-otto denominazioni, Bordeaux è una grande area che include molte denominazioni. Il consumatore non sa se sta bevendo un Saint-Émilion o un Margaux, ma sa che sta bevendo Bordeaux. In Italia dovremmo percorrere questa strada, mettendo insieme le denominazioni in grandi aree riconoscibili. Ma ci vorrà tempo, perché siamo molto campanilisti. La chiave è creare un sistema in cui ogni denominazione si integri in modo coerente e credibile, con l’obiettivo di esprimere davvero il valore del territorio.
L’idea di aprire le cantine e attrarre maggiormente i consumatori è condivisa da molti, soprattutto per attrarre i giovani. Tuttavia “tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare” e sono poche le aziende aperte durante i fine settimana e che propongono, in maniera costante, aperitivi o eventi. Quali sono le motivazioni secondo lei?
Aprire la cantina per accogliere il pubblico è una strada che porta grandi risultati, ma è costosa e richiede impegno. Il viticoltore non può fare tutto: in questo caso si tratta non solo di essere produttore, ma anche insegnante e formatore. E, purtroppo, spesso manca l’energia per gestire tutto. Chi riesce a farlo, ha intrapreso una strada bellissima e fruttuosa. Noi, ad esempio, abbiamo avuto 10.000 presenze l’anno scorso, con 7.000 acquisti di vino e 3.000 visite alla cantina. Ma l’obiettivo non è solo vendere vino: l’obiettivo è stimolare una memoria emozionale che rimanga nel visitatore. E quando qualcuno prova un’emozione, la comunica a centinaia di altre persone. Questo è il vero valore di aprire le cantine al pubblico.
Punti chiave:
- Longevità come filosofia produttiva: Mattia Vezzola rigetta l’idea del vino come prodotto da consumo rapido, puntando su una viticoltura che esprime valore nel tempo. Il suo “rosé da viticoltura” è il frutto di decenni di lavoro su un territorio vocato come la Valtènesi.
- Il rosé non è un vino semplice: Vezzola distingue tra rosé da uva e rosé da viticoltura: solo quest’ultimo nasce da una gestione agronomica specifica e coerente, frutto di almeno tre generazioni di esperienza.
- L’identità geoclimatica come valore competitivo: Secondo Vezzola, il futuro della competitività internazionale si gioca sulla capacità di raccontare le identità territoriali in modo chiaro e riconoscibile, superando il campanilismo italiano.
- Critica ai “vini della disperazione”: Il produttore mette in guardia dall’inseguimento di trend poco coerenti, come il no/low alcohol, e ribadisce l’importanza di rimanere fedeli alla vocazionalità per creare prodotti vitali e duraturi.
- Accoglienza in cantina come atto culturale: Aprire le cantine al pubblico non è solo un’attività commerciale, ma un modo per creare una memoria emozionale nel consumatore. Tuttavia, è un impegno che richiede risorse, professionalità e visione.