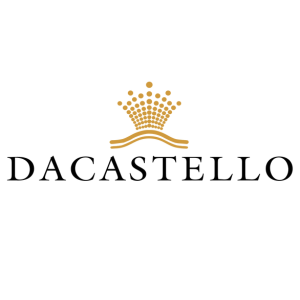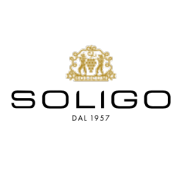Nicola Pasquero Hilberg racconta la visione della cantina Hilberg-Pasquero nel Roero e propone un cambio di paradigma per la carta vini: meno “prezziario”, più orientamento. Suggerisce di organizzare l’offerta per profili di gusto e abbinamenti, con categorie chiare e scelte guidate, usando un linguaggio semplice e, se utile, strumenti digitali.
Nel cuore del Roero, a Priocca, a pochi minuti dalle colline più celebri delle Langhe ma ancora lontano dai grandi flussi turistici, si trova Hilberg-Pasquero: una cantina familiare che da decenni lavora su un’idea di vino profondamente legata alla vigna, al territorio e a una visione agricola coerente e radicale.
Fondata dai genitori di Nicola Pasquero Hilberg, l’azienda ha costruito nel tempo un’identità riconoscibile basata su pratiche biodinamiche, su una forte attenzione alla biodiversità e su un approccio artigianale che rifugge le scorciatoie produttive e comunicative.
Oggi Nicola rappresenta la nuova generazione della cantina e porta questa visione anche su un piano più ampio: quello dell’esperienza del vino, dell’enoturismo e del modo in cui il vino viene raccontato e proposto al consumatore finale.
Nel vostro manifesto parlate spesso di autenticità e sostenibilità, ma soprattutto di “bioergodinamica”. Cosa significa esattamente?
Per noi non sono concetti di marketing, ma un modo di lavorare che viene da lontano. L’azienda nasce come realtà agricola completa, non solo vitivinicola, e questo ha sempre portato a un approccio molto diretto alla terra. L’idea è semplice: ciò che fai in vigna torna, prima o poi, nel bicchiere.
“Bioergodinamica” è un termine che abbiamo sviluppato perché sentivamo che “biologico” o “biodinamico”, da soli, non descrivevano completamente il nostro approccio. “Ergon” significa lavoro: per noi il lavoro dell’uomo non è necessariamente un elemento negativo in agricoltura, può essere anzi un fattore positivo se guidato da osservazione, conoscenza e responsabilità.
In pratica significa applicare i principi della biodinamica: come il sovescio, la gestione differenziata delle parcelle, la biodiversità in vigna, ma senza rinunciare al ragionamento agronomico e scientifico.
L’obiettivo non è massimizzare la produzione, ma ottenere piante in equilibrio, che producano meno uva ma con maggiore concentrazione e identità. Questo si traduce poi direttamente nel bicchiere: vini più profondi, più longevi e più riconoscibili.
Questo approccio si riflette anche nel modo in cui accogliete le persone in cantina?
Assolutamente sì, perché oggi non si parla più solo di vino, ma di esperienza. Per molto tempo da noi arrivavano soprattutto appassionati che acquistavano e ripartivano. Ora cresce un pubblico che vuole fermarsi, capire, vivere il luogo. Stiamo riflettendo su modelli di accoglienza più flessibili e contemporanei, meno legati all’idea classica di visita guidata obbligatoria. Ci piacerebbe sviluppare una formula self-managed in cui il visitatore può arrivare, acquistare un pacchetto degustazione (tre o quattro vini), accomodarsi all’esterno, con vista sui vigneti del Roero, ricevere un tagliere di prodotti locali e vivere l’assaggio in autonomia, con i propri tempi. È un modello molto diffuso in altri paesi, che mette al centro la libertà dell’ospite e il piacere dell’esperienza.
Naturalmente richiede strutture adeguate, personale formato e investimenti importanti, ma crediamo che rappresenti una direzione interessante per rendere l’enoturismo più accessibile e rilassato, coerente con i ritmi delle persone di oggi.
Venendo al tema della carta vini. Se un ristorante ti chiedesse come costruirne una moderna e realmente efficace, da dove partiresti?
Dal cliente, non dal vino. Il ristorante è un contesto specifico: il vino vive in relazione al cibo e all’occasione. Eppure molte carte sono ancora organizzate secondo logiche interne al settore, denominazioni, disciplinari, regioni, che per il consumatore finale contano relativamente.
Dal mio punto di vista una carta vini contemporanea dovrebbe basarsi su alcuni principi chiave:
- organizzazione per profilo di gusto, non solo per origine geografica;
- poche categorie chiare, sia per i bianchi che per i rossi (sette, otto al massimo);
- scelte guidate e limitate, idealmente tre opzioni per categoria, perché facilitano il processo decisionale;
- linguaggio semplice e comprensibile, non tecnico.
All’interno di queste categorie possono convivere vini naturali, convenzionali, con o senza denominazioni importanti: ciò che conta è che rispondano allo stile dichiarato.
Oggi però molte carte vini assomigliano a un listino prezzi. È davvero un problema?
Sì, perché quando una carta diventa un prezziario, il cliente sceglie in base a ciò che riconosce e a quanto vuole spendere. L’esperienza si appiattisce. La carta dovrebbe invece aiutare a scoprire, orientare, incuriosire. Esistono anche soluzioni grafiche per ridurre l’attenzione sul prezzo, ma il punto centrale resta la progettazione dell’esperienza.
In questo senso il digitale può giocare un ruolo?
Sicuramente. Digitale e cartaceo non si escludono, possono convivere. Una carta digitale ben pensata potrebbe, per esempio, permettere al cliente di selezionare ciò che ha ordinato: carne, pesce, vegetariano, piatti speziati, e ricevere suggerimenti mirati per il calice o la bottiglia più adatta. In pratica un sistema di filtri basato sul cibo, che aiuti a individuare rapidamente due o tre opzioni coerenti con il piatto e con le preferenze personali. È uno strumento molto potente, soprattutto per chi non ha grande dimestichezza con il vino. Naturalmente il ristorante resta un ambiente complesso: spesso al tavolo si ordinano piatti diversi, si decide insieme, si vuole un vino “trasversale”. Anche per questo stanno crescendo bianchi più strutturati e rossi più leggeri, capaci di adattarsi a più abbinamenti.
Se dovessi progettare tu una carta vini ideale, al di là della struttura tecnica, quale dovrebbe essere il suo linguaggio? Come dovrebbe parlare al cliente?
Credo che una carta vini moderna debba fare uno sforzo di traduzione culturale. Il vino è complesso, ma il cliente non deve essere obbligato a diventare un tecnico per scegliere con serenità. Negli Stati Uniti, per esempio, questo approccio è già molto diffuso: si utilizzano parallelismi con ciò che le persone conoscono. Dire “questo è il Barolo” per molti non significa nulla; dire “questa è la Borgogna d’Italia” invece attiva subito un riferimento, un’immagine mentale, un profilo di gusto. È un modo per creare empatia e orientamento senza banalizzare.
Lo stesso vale per il racconto legato allo stile di vita. Nel mondo del vino siamo abituati a descrivere un’etichetta parlando di clone, di tipo di botte, di suolo, di disciplinare. È un po’ come vendere una giacca spiegando il codice della zip o il Pantone del colore. In altri settori funziona diversamente: si associa il prodotto a una persona, a un contesto, a un immaginario. Dire che un vino è “il preferito di…” oppure che rappresenta un certo modo di vivere crea immediatamente una connessione emotiva.
Non si tratta di svuotare il vino del suo contenuto culturale, ma di cambiare il punto di accesso. Prima coinvolgere, poi, se il cliente è curioso, approfondire. Oggi la maggior parte delle persone che entra in un ristorante non cerca una lezione di enologia, ma un’esperienza piacevole, coerente con quello che sta mangiando e con l’idea che ha di sé in quel momento.
Una carta vini ideale, per me, dovrebbe fare proprio questo: accompagnare il cliente, parlargli in modo chiaro e contemporaneo, e solo dopo, per chi lo desidera, entrare nel dettaglio tecnico.
Guardando al futuro del vino, tra mercato, comunicazione e social media, cosa ti auguri per i prossimi anni? Cosa dovrebbe cambiare per andare nella direzione giusta?
Mi auguro che continui a crescere una curiosità autentica, non superficiale. Una curiosità legata alla qualità, ai territori, al lavoro reale che c’è dietro una bottiglia. Se potessi usare una bacchetta magica, chiederei anche un cambiamento nel modo in cui il vino viene raccontato sui social, soprattutto su Instagram. Oggi moltissimi post sono legati al prezzo: si mostra la bottiglia costosa come simbolo di status. Funziona, attira attenzione, ma non costruisce cultura.
Mi piacerebbe vedere più contenuti legati alla qualità del prodotto, alla coerenza di un progetto, al lavoro in vigna e in cantina, non al valore economico dell’etichetta. Credo che questo spostamento, dallo status alla qualità, sarebbe sano sia per i consumatori sia per i produttori, e aiuterebbe anche il mondo del vino a rinnovare il proprio linguaggio senza perdere profondità.
Punti chiave
- Carta vini moderna: partire dal cliente, non da denominazioni e tecnicismi.
- Profili di gusto: organizzazione per stile e abbinamenti, non solo per geografia.
- Scelte guidate: poche categorie chiare e opzioni limitate per decidere più facilmente.
- Linguaggio semplice: empatia, riferimenti immediati e storytelling prima della tecnica.
- Digitale utile: filtri per piatti e preferenze per suggerire 2–3 vini coerenti.