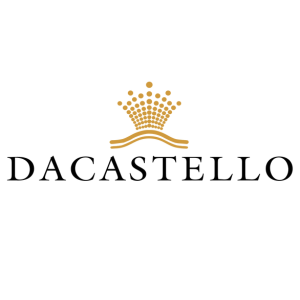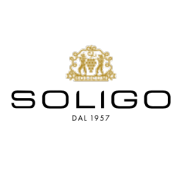In questa intervista esclusiva, Giulio Armani, storico enologo de La Stoppa e fondatore di Denavolo, esplora il sottile confine tra tecnica e identità. Attraverso quarantasei vendemmie, Armani difende il valore del vino naturale in grado di esprimere appieno il territorio e invita a riscoprire un gusto libero dalle manipolazioni industriali, dove l’uomo fa finalmente un passo indietro per lasciar parlare il terroir.
Ci sono uomini che non hanno bisogno di alzare la voce per farsi ascoltare; a parlare per loro sono le esperienze, le mani, segnate da quarantasei vendemmie, e il silenzio di chi ha scelto, per mestiere e per indole, di fare un passo indietro per lasciar parlare il terroir. Giulio Armani non è solo l’enologo che ha legato il suo nome alla storia de La Stoppa o l’architetto sensibile del progetto Denavolo; è, prima di tutto, un testimone lucido di un’epoca di transizione.
In questa intervista esclusiva, Armani non si limita a discutere di protocolli o di vitigni, ma lancia una riflessione profonda su come il nostro palato sia diventato pericolosamente “addomesticato” da un’industria che preferisce la rassicurazione del difetto rimosso alla complessità della realtà. Con l’equilibrio di chi ha visto passare generazioni e mode, Giulio mi ha raccontato perché la macerazione non è un vezzo stilistico ma un ritorno all’integrità, e perché la vera competenza oggi non risieda nel correggere la natura, ma nel coraggio di assecondarne le peculiarità.
Ne emerge il ritratto di un vignaiolo che rifugge i dogmi del mercato per difendere un’idea di vino come entità territoriale e culturale: una bevanda conviviale che non deve necessariamente “scivolare via”, ma che ha il compito di disturbare, invitare al confronto e, infine, durare. È un invito a riscoprire la bellezza della complessità, della variabilità di un terroir che, se lasciato libero di esprimersi, sa ancora come stupirci.
Parlando del confine tra vino tecnico e identitario: spesso si commette l’errore di pensare che il vino “naturale” nasca dall’assenza di tecnica. Al contrario, la sua esperienza suggerisce che serva molta più competenza per assecondare la natura che per correggerla. In un mondo che tende a polarizzarsi tra “enologia interventista” e “naturalismo radicale”, come definirebbe il punto di equilibrio?
Siamo a 45 vendemmie, e questa è la quarantaseiesima. In tutti questi anni ho visto il mondo cambiare radicalmente. Il problema oggi è che il nostro gusto è stato alterato: non si produce più pensando a un vino sincero, ma a un modello che soddisfi un palato addomesticato e infantile. Come scriveva Michel Legris in “Dioniso Crocifisso”, la comunicazione e i media hanno promosso un’idea di gradevolezza che prescinde dall’annata e dal terroir.
Se vogliamo rivolgerci alla massa, siamo quasi costretti a intervenire; l’enologia diventa uno strumento per essere “bravi imprenditori”, costruendo vini che non disturbino nessuno, un po’ come i prodotti industriali o le merendine. Il punto di equilibrio, quindi, diventa una questione estremamente personale: è una fune tesa tra il desiderio di autenticità e la necessità economica di far stare in piedi l’azienda. Spesso ci accusano di non essere buoni imprenditori perché non siamo conformi agli standard di mercato, ma l’equilibrio vero è quello che ognuno si cuce addosso sperando che il tempo gli dia ragione.
Il suo approccio con la macerazione sulle bucce per i bianchi (orange wine) non è una moda, ma una ricerca di integrità. Eppure, oggi il mercato sembra premiare lo “stile macerato” a prescindere dal terroir. Non teme che la macerazione stia diventando essa stessa una “tecnica coprente” tanto quanto i lieviti selezionati?
Si dice spesso, ma credo sia l’esatto opposto. Io vengo da una famiglia di agricoltori; i miei nonni maceravano i bianchi per necessità e tradizione: il vino era un alimento, serviva energia per lavorare i campi. Negli anni ’80 abbiamo commesso l’errore di importare tecnologie nate per climi nordici, come la pressatura soffice. Nei climi nordici non macerano perché l’uva non matura abbastanza, ma da noi, dove il sole non manca, tutta la qualità è nella buccia.
Separare immediatamente il mosto dalle bucce significa privare il vino della sua anima aromatica e strutturale, costringendoci poi a “curare” o proteggere chimicamente un mosto fiore che è intrinsecamente debole. La macerazione non copre, la macerazione svela. Ci permette di scoprire il vero volto di vitigni come il Sauvignon o il Trebbiano, che per anni abbiamo cercato di far somigliare a modelli stranieri (come il Sancerre, per esempio) che nulla avevano a che fare con il nostro clima e i nostri suoli.
Lei ha vissuto decenni a La Stoppa e poi ha creato Denavolo. In che modo la libertà totale del progetto personale ha cambiato il suo modo di interpretare il concetto di “millesimo”? È più difficile accettare le imperfezioni di un’annata quando il nome sull’etichetta è interamente il proprio?
Denavolo è nata nel 2005 proprio per una sfida: dimostrare che nei vini della Stoppa non si sentiva “la mano di Armani”, come qualcuno sosteneva, ma il territorio. Io faccio sempre un passo indietro, e due se necessario, perché l’uomo deve restare in ombra. Non parlerei di imperfezioni, ma di espressione del millesimo. Un 2017 caldo e un 2018 fresco devono essere diversi; è una questione di onestà culturale.
Prendiamo l’Ageno o la Macchiona: sono “mostri” per l’enologia canonica perché subiscono spesso arresti di fermentazione. Invece di forzarli, li lasciamo liberi. Lieviti e batteri specifici della nostra zona, del nostro terroir , concorrono a trovare un equilibrio nel vino finale. Per noi il Brett o la volatile non sono tabù, ma veicoli aromatici che aumentano la bevibilità e la serbevolezza, a patto che siano figli di quel processo naturale e non di negligenza. Se un vino “tecnicamente perfetto” non si fa bere, allora è quello il vero fallimento.
Si parla spesso di “vini gastronomici”. Per lei il vino deve essere un accompagnamento al cibo o un’entità autosufficiente che racconta una storia culturale? In altre parole, la piacevolezza della beva è un fine o una conseguenza dell’identità?
Il vino deve essere prima di tutto un’entità autosufficiente e un fatto culturale. Poi, se è fatto bene, l’abbinamento col cibo diventa una conseguenza naturale che ne esalta la piacevolezza. La beva, però, è influenzata da troppi fattori: l’umore, la stagione, persino la polvere respirata durante il lavoro in vigna. Mi capita di godermi uno Champagne in una sera d’estate dopo la campagna, ma d’inverno non mi sognerei mai di stapparlo. La piacevolezza è soggettiva, l’identità del terroir è l’unica costante.
Molti critici sostengono che certi vini “naturali” siano accomunati da difetti che ne annullano l’espressione varietale. Qual è il limite oltre il quale il carattere di un vino smette di essere “anima” e diventa semplicemente “negligenza enologica”?
Dobbiamo distinguere tra l’inesperienza di alcuni giovani produttori e la scelta consapevole di chi conosce il mestiere. Assecondare la natura richiede molta più competenza che correggerla. L’espressione varietale non è un dogma assoluto: non esiste il Sauvignon “perfetto” in laboratorio, esiste il Sauvignon di quel vigneto in quell’annata. I vini “naturali” diventano criticabili solo se usiamo come parametro i punteggi standardizzati che ignorano le realtà locali. Per me, solo un vino non manipolato può davvero raccontare un territorio; se aggiungi sostanze per “aggiustarlo”, stai parlando d’altro.
La Malvasia di Candia Aromatica è un’uva complessa, a volte prepotente. Nel Dinavolo, lei sembra volerla spogliare dell’esuberanza aromatica per cercarne la struttura minerale. È una sfida alla natura del vitigno o un modo per rivelarne un lato più intimo e meno “tecnico”?
Non è una sfida tecnica, è ancora una volta il terroir. A La Stoppa, con l’Ageno, lavoriamo su terreni argillosi e caldi a 200 metri d’altitudine. A Denavolo siamo a 500 metri: qui la Malvasia matura diversamente, l’espressione aromatica si fa più sottile, fresca e contenuta, lasciando spazio alla mineralità. Non sono io che “spoglio” l’uva, è l’altitudine che ne cambia la voce.
Esiste un falso mito secondo cui il vino “vero” debba essere per forza difficile o respingente al primo sorso. Come si concilia la profondità di un vino con la necessità democratica di essere, dopotutto, una bevanda conviviale?
Il vino è giudicato “difficile” solo da chi non vuole essere disturbato mentre beve. Stiamo scivolando verso un’anosmia collettiva, dove cerchiamo aromi e sapori neutri e rassicuranti. Al contrario, io credo che un vino profondo e complesso favorisca il confronto e la socialità. Se un vino è troppo semplice, scivola via senza lasciare traccia; se ha carattere, invita le persone a discutere, a interrogarsi, a vivere la convivialità in modo più autentico e meno passivo.
Se guardiamo al futuro, vede più minacce nella burocrazia delle denominazioni o nell’eccessiva frammentazione del movimento del vino naturale, che rischia di perdere credibilità a causa di una comunicazione a volte troppo ideologica?
Le DOC hanno fatto il loro tempo: oggi servono quasi solo a chi ha grandi budget di marketing. In alcune zone, la DOC è diventata un livellamento verso il basso. Sul fronte del “naturale”, la frammentazione nasce dalla paura di definire regole chiare. Per me è semplicissimo: vino naturale significa “nessuna aggiunta”.
Invece ci si perde a discutere se il limite dei solfiti debba essere 30, 40 o 50 mg. Questa ambiguità spaventa molti produttori, ma il consumatore oggi è informato, frequenta le fiere, ci tempesta di domande su WhatsApp. La credibilità non si perde per mancanza di un disciplinare, ma per mancanza di trasparenza. Chi lavora bene non ha nulla da nascondere.
Lei ha visto passare generazioni di vignaioli. Qual è l’insegnamento più prezioso che ha ricevuto dalla terra e che oggi vede ignorato da chi si avvicina a questo mestiere con un approccio troppo “marketing-oriented”?
L’insegnamento più grande è l’ascolto. Spesso siamo troppo concentrati sul mercato per sentire cosa ci dice la natura. Ai giovani dico sempre: imparate l’ABC dai vecchi, come ho fatto io 45 anni fa, ma poi guardate la pianta. Quando potate, osservate come la vite ha reagito ai tagli dell’anno precedente. È la pianta stessa che ti insegna come trattarla. Non esistono santoni o consulenti che possono spiegarti un territorio meglio dell’osservazione diretta.
Dopo anni di sperimentazioni tra Catavela, Dinavolino e Dinavolo, qual è il messaggio che vorrebbe rimanesse impresso in chi stapperà una sua bottiglia tra dieci anni?
Ho conservato bottiglie fin dalla prima annata 2005 per capire l’evoluzione del nostro lavoro. Recentemente ho portato in giro dei 2005 e la gente è rimasta stupita. Il messaggio è semplice: il vino parla chiaro. Se lavori con rispetto, il vino non solo dura, ma migliora, si evolve e smentisce il pregiudizio secondo cui i vini naturali siano fragili. La longevità è la prova finale della bontà di un metodo.
Punti chiave:
- La competenza tecnica nel vino naturale è fondamentale non per intervenire, ma per avere la capacità di assecondare i processi naturali senza forzature.
- Il palato contemporaneo è stato addomesticato da un’industria che privilegia sapori neutri e rassicuranti, penalizzando i vini autentici e legati al terroir.
- La macerazione sulle bucce non è una tecnica coprente o una moda, bensì l’unico strumento capace di estrarre la vera anima e la qualità del vitigno.
- Le cosiddette anomalie enologiche, come gli arresti di fermentazione o la volatile, possono contribuire alla bevibilità e alla longevità naturale del vino.
- Il vino deve essere considerato un’entità culturale autosufficiente: il suo valore risiede nella capacità di raccontare una storia, un’annata e un territorio specifico.